TESTIMONIANZE
UNA TESTIMONIANZA INEDITA E MOLTO TOCCANTE ARRIVATA IN REDAZIONE:
Mio padre si chiamava Umberto Scorsolini.
Salve, mio padre fu imbarcato sul Nova Scotia, ma il suo nome non figura su nessuna lista, lui raccontava che due giorni prima che lo imbarcassero era fuggito per la terza volta, la seconda dal campo 308, ma ricatturato dopo poche ore, lo portarono direttamente alla nave Nova Scotia un’ora prima di salpare.
Mi raccontava di un carabiniere che insieme a lui aspettarono che la nave fosse quasi affondata per abbandonarla. Avevano visto che qualcuno saltava sopra gli altri dall'alto uccidendosi o ferendosi, lui usava dire: “si sbudellavano”.
Poi lui, con il carabiniere, si legarono con le cinture dei pantaloni ad un tavolone, e raccontava del banchetto dei squali e altri pesci che mangiavano i resti dei poveri naufraghi.
Raccontava che se toccavi qualcuno poi si rovesciava e sotto non aveva piu' niente perché era stato divorato.
Poi raccontava di una forte burrasca e mare mosso, loro sempre legati al tavolone ma semi immersi in acqua e lottarono durante la burrasca per non rovesciarsi, poi mio padre sfinito perse conoscenza e si risvegliò in un ospedale presso Durban, sette giorni dal naufragio e non seppe più niente del carabiniere se si salvò, lui da allora non mangiò più il pesce per tutto il resto della sua vita.
Mio padre si chiamava Umberto Scorsolini, io Vitaliano Scorsolini.
Fu internato a Durban poi andò a lavorare in una fattoria grandissima, lui e un altro italiano dovevano piantare patate, proveniva dall'Umbria ed era agricoltore e sapeva che le patate bisognava tagliarle e piantarle con gli occhi con germogli, cosi fecero per una quindicina di giorni, quando arrivò il proprietario vedendo che le patate erano avanzate e tagliate li denuncio' per sabotaggio, mio padre si fece 15 giorni di “casetta rossa”, era una baracca di lamiera verniciata di rosso, un metro e mezzo per un metro e mezzo x 1,70 al sole, uscì vivo che non sapeva come aveva fatto. Al momento della raccolta, al fattore, dove mio padre e l'altro avevano piantato le patate, venne una raccolta incredibile per quantità e qualità e andò a cercarlo al campo per convicerlo a tornare al lavoro, ma lui lo mandò al diavolo.
Dopo l’8 settembre gli chiesero se voleva rimanere nei campi di prigionia o tornare in Italia da cooperatore, lui non ci pensò su molto e accettò di tornare in Italia, lo imbarcarono su di una nave inglese insieme ad altri trecento Italiani cooperatori, dopo 15 giorni di navigazione, invece di arrivare in Italia sbarcarono in Australia, dove furono vestiti, calzati e armati, poi andarono al seguito degli inglesi nel sud est asiatico, dapprima li usavano come guardie ai depositi, ai campi di aviazione, poi vennero utilizzati nei rastrellamenti e bonifiche, e quando iniziarono a fidarsi di loro, combatterono a fianco degli inglesi contro I giapponesi, quando esplose la prima bomba “H” stavano a Hokinawa.
Una volta che ebbero aderito, li portarono in un campo vicino a delle miniere di diamanti dove vennero tenuti dei mesi, ma poterono lavorare fuori dal campo e poi li portarono a bordo su di una nave, controllarono tutti I documenti e trovarono un cappellano militare che aveva una ferita ricucita in una gamba, ma dai documenti non risultava nulla, alla fine trovarono che si era cucito dentro due diamanti grezzi, che qualcuno della popolazione gli aveva dato, fecero allora spogliare tutti nudi e diedero per due giorni di fila a tutti la purga, la nave era diventata una fogna dappertutto, piena di escrementi che poi lavarono con gli idranti e li fecero trasbordare in un’altra nave, abbandonando così sulla vecchia tutti gli averi e il vestiario che non fu mai più restituito e dovettero indossare dei pantaloni corti e basta senza scarpe.
Una volta giunti a Sidney, furono rivestiti e calzati, con divise inglesi, mio padre raccontò che molti morirono, sopratutto in un’isola vicino a Ceylon, dove I giapponesi vennero a sapere che con gli inglesi combattevano anche loro ex alleati, spostando così il loro bersaglio e sprigionando la loro massima crudeltà contro il reparto italiano.
Vitaliano Scorsolini
Direttamente dal racconto di un sopravvissuto fa seguito l’articolo pubblicato sulla “Domenica del Corriere” n. 47 del 25 novembre 1962.
A ripensarci mi vengono i brividi
Un nostro compagno di lavoro, Carlo Dominione, si è lasciato finalmente convincere a raccontare una spaventosa avventura da lui vissuta durante l’ultima guerra.
Il 28 novembre 1942, alle ore 7.07 il dottor Gino Caldiron e Luigi Butturini erano con me in una cabina comando del piroscafo britannico “Nova Scotia” che ci portava, prigionieri, nel Sud Africa, quando entrò il cap. Romney, comandante inglese del campo di Dekamerè che veniva trasferito a Fort Victoria, vicino alle famose cascate. A bordo erano 769 prigionieri italiani, e alcune centinaia di boeri rimasti feriti ad El Alamein; compresi i militari di guardia e l’equipaggio, 1200 persone. Eravamo al largo della costa del Natal, navigando prudenzialmente a zig zag perché in quelle acque erano stati segnalati dei sommergibili tedeschi.
Avevamo lasciato Massaua il 15; il 19 ad Aden fu sbarcato un nostro compagno colto da appendicite. Dei prigionieri italiani, la maggior parte proveniva dagli equipaggi di navi che la guerra aveva bloccato in Eritrea, come il “Tevere, il “Colombo”, il “Mazzini”, poi autoaffondati prima della occupazione. Altri, come civili che per un motivo o l’altro non erano graditi agli occupanti.
Al tramonto saremo a Durban – disse subito il comandante Romney. – Date disposizioni perché lo sbarco avvenga nel massimo ordine. Mi raccomando marciate come vi ha insegnato a fare Mussolini… Non terminò la frase; l’esplosione ci scaraventò a terra.
Ecco l’U Boot
Tre siluri, un solo schianto come se un gigantesco maglio fosse calato sulla nave; una voragine a sinistra all’altezza delle macchine; torrenti di nafta che dilagano sull’oceano, fiamme che esplodono dal basso, serpeggiano per le stive, i corridoi, dai boccaporti, avvolgono i ponti a prua. Distruzione e morte; urla di feriti, gente che corre non sa dove, invocazioni, grida, pianti, bestemmie.
Mi trovai nel corridoio: all’estremità verso prua balenarono le prime fiamme; avevo perso un sandalo, buttai l’altro e corsi verso la scala che portava al ponte superiore. Sul secondo gradino trovai un salvagente abbandonato; l’indossai e mi cacciai nel formicaio impazzito. Cercavo anch’io una lancia. Correvo in salita: il “Nova Scotia” era tutta inclinata a sinistra, l’acqua raggiungeva la prima passeggiata. Udii una voce che mi chiamava. Era Butturini. - Carlo qui c’è un posto. Stavano calando la prima lancia di dritta; c’era ancora un posticino all’estrema poppa. M’accucciai accanto all’amico. I paranchi erano in fuori, le carrucole cigolarono per un’ istante, poi uno strappo e il cavo poppiero si ruppe; la grossa imbarcazione volò con il suo carico trattenuta dal cavo di poppa. Non esitai, mi volsi di scatto gridando “Butturini lanciati” e mi tuffai. Un’onda mi prese di sbieco, gettandomi contro la carena; la nafta mi aveva accecato, alzai un braccio e m’aggrappai ad una cima che pendeva inerte. In quell’istante, mentre tentavo di pulirmi gli occhi col dorso della mano libera, lo zatterino entrò nella mia vita di naufrago.
Dall’alto i più animosi ne buttavano a decine mentre le grosse zattere, spezzati i cavi, scendevano lungo gli scivoli sollevando alti spruzzi, uccidendo quanti si trovavano sulla loro traiettoria. La morte continuava a mietere; ma ciascuno pensava a sopravvivere. Con quattro bracciate raggiunsi lo zatterino (un metro e mezzo per ottanta di travetti incrociati, con maniglie di canapa intorno) e nuotai spingendolo finché mi sentii stremato. Quando mi volsi ansando; il “Nova Scotia” era a cento metri da me; la poppa alta con le eliche scintillanti al sole: affondava di prua e la murata di poppa era un groviglio di uomini. Come un rullar sordo di tamburi, mi giungevano le urla, le invocazioni. Poi un gorgoglio forte, un sibilo rauco e anche quell’ultimo ridotto sparì. Sul primo atto del dramma era sceso il sipario liquido dell’oceano. Erano le 7.14. Sette minuti erano trascorsi e cominciavano le ore dell’agonia.
Altri mi raggiunsero, tra cui il tenente Gallard, un rodesiano che parlava italiano. Ben presto fummo in dieci attaccati alle maniglie dello zatterino. C’era anche Bruno Trebbi. A venti metri da noi, l’”U-Boot” affondatore. Un ufficiale stava cinematografando l’affondamento. Sulla torretta il comandante, il volto incorniciato da una folta barba nera. Si udiva il ronzio degli accumulatori che si ricaricavano. Poi il comandante portò un fischietto alle labbra: due sibili ed un ordine ad alta voce. Fu Trebbi a capirne il significato: “Ragazzi – urlò – ci mitragliano”. Due marinai s’erano diretti alla mitragliatrice di prua, per scappucciarla. Fu un attimo: e il grido “Italia! Italia!” si levò da quelle poche centinaia di superstiti. Vicino a me Gallard si unì al coro, cantando “ La donna è mobile..”. Trebbi urlò qualcosa in tedesco. Il comandante gridò un ordine: dal sottomarino vennero lanciate delle gomene e tirati a bordo due di noi. I minuti trascorsero lenti, in gran silenzio: poi il tedesco gridò qualcosa, che Trebbi Tradusse: “Dice di aver lanciato l’S.O.S. dobbiamo cercare di restare uniti il più possibile. Verranno a salvarci.
Ad uno a uno.
L’”U-Boot” di lì a poco s’immerse. Attorno a noi i segni della morte: travi e casse, arance e pane, corpi dai volti violacei. Quattro grandi zatteroni erano gremiti; a decine attorno le piccole zattere, contornate da teste a pelo d’acqua.
La nafta aveva patinato i corpi, bruciava le congiuntive, provocando vomiti continui ed estenuanti. Poi le correnti ci dispersero. Trebbi se ne era andato e non l’ho più rivisto. Anche Delmo Bignami, che mi aveva raggiunto a nuoto, mi aveva lasciato per cercare una sistemazione migliore. Pure di lui non ho saputo più nulla. Uno dei tanti spariti nell’immensità dell’oceano.
Le ore, fino al tardo pomeriggio, trascorsero tranquille; il mare era calmo. Sembrava che lo spettro della morte fosse svanito. Si parlava poco e le rare parole erano di speranza. Poi, all’improvviso, un marittimo anziano, calvo, proprio alla mia destra, ebbe un gemito; le mani avevano lasciato l’appiglio e il suo corpo fluttuava all’indietro tenuto a galla dal salvagente. Gli tastai il polso. Più nulla. Ci guardammo in silenzio; non passò molto e, quando già il sole era tramontato e l’acqua s’incupiva di ombre e di freddo, un altro cominciò a borbottare parole sconnesse, la testa piegata su una spalla. Un gorgoglio rauco gli usciva dalle labbra chiuse. Lo sollevammo per le ascelle; mi cadde addosso inerte. Lo abbandonammo, ma continuò a seguirci sulla scia della zattera alla deriva.
La notte tropicale scese fulminea, trapuntata di stelle e da una esile fetta di luna che laminava d’argento l’acqua. Ci trovammo di sorpresa in sette; un altro se ne era andato, sfilandosi il salvagente, imitato nel giro di un’ora da altri due. La pazzia. Come si poteva sperare? Appoggiai la fronte al legno della zattera, chiusi gli occhi e piansi. Sentivo il respiro forte dei miei compagni, udivo i loro lamenti, le invocazioni. Gli stessi loro pensieri mi battevano ossessionati nel cervello: era la fine!
“Pater noster qui es in coelis…”…”Panem nostrum quotidianum…”…”Ave Maria…”…”Sancta Maria, Mater Dei…”: un altro zatterino si era accostato al nostro. Ellero recitava il Rosario e i suoi compagni rispondevano, sotto la grande navata del cielo, aggrappati a quelle poche tavole incrociate. Lo chiamai; Ellero mi rispose con un gesto della mano, e con la sua solita voce serena e buona: “Pregate,… pregate anche voi… solo Dio ci può aiutare”.
Furono le sue ultime parole. Poi il mare cominciò ad ingrossare e le onde ci dispersero.
Quel breve attimo di pace non durò a lungo: eravamo rimasti in cinque e ci davamo il cambio a turno: due stesi sullo zatterino, gli altri in acqua. Era poco, ma serviva a stendere le gambe rattrappite dal freddo. Ad un tratto un’ondata ci capovolse, rotolammo; sentii uno spigolo strapparmi un fianco. Riacciuffai la zattera non so come; anche gli altri ci erano riusciti. Ma bastò quello perché la follia riesplodesse. In due s’azzuffavano accusandosi a vicenda di essersi rubato il salvagente, uno aveva afferrato l’altro per il collo e gli gravava addosso con tutto il peso; l’altro picchiava sul volto dell’assalitore; cercammo di separarli; si formò un groviglio; un’ondata ci coperse, lo zatterino s’inalberò rovesciandosi nuovamente. Riemersi sputando acqua e sangue, una gomitata m’aveva spaccato un labbro; nuotai disperatamente verso lo zatterino già lontano alcuni metri. Poco oltre un altro nuotava trascinando qualcosa; colui che era stato assalito, non ne aveva per molto. Lo stendemmo sulla zattera; perdeva sangue da un largo squarcio alla gola; il risvolto in corda del salvagente gliela aveva segata. Si lamentava, debolmente, ansimando.
Eravamo rimasti in due con quel moribondo. Il mare s’era fatto sempre più grosso; salivamo e scendevamo tra pareti d’acqua che parevano le mura di un carcere spaventoso. Ad un tratto frustate di fuoco ci colpirono alle gambe, al torace. Le meduse: l’acqua ne era iridescente. Ce le strappavamo di dosso urlando, ed altre si avvinghiavano bruciando come piombo liquido. Per fortuna quel tormento durò pochi minuti.
L’alba s’annunciò livida; attorno a noi solo un mare bianco di spume ribollenti; sulla zattera un cadavere. Lo spingemmo in acqua. Io e Salvatore, un ciabattino siciliano, eravamo gli unici sopravvissuti di quella notte di terrore. Ci stendemmo sullo zatterino e ci addormentammo. Quando riemergemmo da quel torpore il sole era alto su di noi; passò un aereo, ma fu una apparizione rapida. Ciò ci confortò, qualcuno sapeva di noi. Poi il cielo si coperse e piovve.
Ci mettemmo supini e lasciammo che l’acqua ci scorresse sul volto, lavandoci le ferite, attenuando il bruciore degli occhi. Dalle labbra riarse e rotte l’acqua filtrava in bocca dissetandoci. Passò un’ora, poi il cielo ridiventò sereno. E fu allora, mentre lo zatterino era su una cresta d’onda, che alzando il capo vidi un fumo all’orizzonte. Scrollai Salvatore; “Una nave!” gridai. Mi guardò senza capire. Lo buttai in acqua. “Tieni lo zatterino – urlai – che ci monto sopra in piedi”. Riuscii a rizzarmi su quelle traballanti tavole, poi ricaddi in acqua. Ma era stato sufficiente: all’orizzonte c’era una nave.
Anche Salvatore aveva visto: là in fondo era la vita. Non ci dicemmo nulla; lui afferrò lo zatterino con una mano e lo trascinò nuotando; io lo spingevo. Per quanto nuotammo? Ad ogni bracciata la nave s’ingrandiva sempre più.
Eravamo forse a mezzo miglio e la sagoma s’intravedeva chiara – un grosso cacciatorpediniere – quando lo vedemmo accostare, allontanarsi, sparire. La faccio finita!
L’ultimo urlo ci morì in gola. Salvatore mi guardò piangendo: “Basta, la faccio finita anch’io”, mormorò e con le mani armeggiò attorno ai legacci del salvagente. “Stupido! – gli urlai. – Se non la pianti ti do due sberle!”, e gli
annodai il legaccio che aveva sciolto. “Perché morire? Non siamo forse ancora vivi? Dobbiamo vivere, capisci? – io continuavo a ripetere. – Aspettiamo domani. Finora non siamo morti, l’hai vista la nave, era lì! Vedrai che tornerà”.
Salvatore mi ascoltava con gli occhi lucidi, ansante; col capo faceva di si. E continuai a parlare perché sentivo che così facendo rassicuravo me stesso.
Capivo che era follia sperare, ma una voce in me sussurrava: “Figliolo mio, non temere. Ci sono io. Sono la tua mamma. Vuoi che ti abbandoni proprio in questo istante? No, non morirai. Vedi, aspetto che tu ritorni, che tu porti sulla mia tomba quel fiore, che attendo da tanto tempo”.
Il miracolo E quella voce, dalla nota accorta cadenza, si vestiva di altre parole; mi parlava dell’infanzia, di anni di tristezze, di tante piccole gioie e cari ricordi. “ Oh, mamma – mormoravo con la testa appoggiata al legno della zattera – lo so che mi sei vicina, che non mi abbandonerai. Non voglio morire prima di aver pianto sulla tua tomba, ma dove troverò la forza per resistere?”. E pregavo e piangevo, mentre cercavo d’illudere Salvatore ad aver fiducia.
Ed il miracolo venne, quando il sole stava per la seconda volta tramontando. La nave rispuntò, ingigantì, puntando proprio verso di noi. Poi si fermò a circa un miglio: e le forze, la volontà di vivere tornarono in noi. Disperatamente ci rimettemmo a nuotare spingendo quel ballonzolante zatterino. Dieci, centro, trecento metri. Ci fermammo esausti. Mi strappai la camicia; salì in piedi sul legno e sventolai quel ciencio urlando. Vedemmo una lancia puntare verso di noi; un marinaio che accennava con un remo; ma l’urlo continuò disperato finchè le nostre mani non afferrarono altre mani.
Davanti a noi era la sagoma dello “Afonso de Albuquerque”; sulla fiancata una grande scritta bianca “Portugal” e vidi i colori, verde e rosso, della bandiera lusitana. Sulla lancia ci strapparono i pochi indumenti fradici che indossavamo e ci scolammo senza accorgercene una fiaschetta di “aguardiente”.
Quando pochi minuti dopo fummo sottobordo dell’”Albuquerque”, Salvatore ed io salimmo la scaletta nudi come ci avevano fatto le nostre mamme. Eravamo nati una seconda volta.
Con noi furono salvi altri 117 italiani e 64 tra sudafricani e inglesi. In tutto 183 dei 1200 del “Nova Scotia”; 650 nostri compagni erano spariti, per sempre, tra le verdi acque dell’Oceano Indiano.
Carlo Dominione
Sul n. 50 della Domenica del Corriere del 16 dicembre 1962 il seguito del racconto aggiunge nuovi particolari.
L’assalto dei pescecani
Una ingiallita pagina di guerra – uno dei tanti episodi di distruzione e di eroismo – quale è quella tornata a colorarsi d’umanità nella palpitante rievocazione dell’affondamento della “Nova Scotia”, apparsa sul n. 47 della “Domenica del Corriere” non poteva suscitare commozione, rinnovando dolorosi ricordi e angosce attese soprattutto in chi più direttamente ne fu colpito. Una generazione è passata, eppure ancora sono in molti coloro che disperatamente si aggrappano, come fecero gli stessi naufraghi, alla zattera della speranza. Le molte lettere giunte alla nostra direzione avranno una risposta diretta. Ma per accontentare anche coloro che vogliono avere un quadro più ampio e completo di quella tragica vicenda, Carlo Dominione, che fu uno dei primi naufraghi ad essere salvato, rievocherà qui l’incontro con gli altri superstiti a bordo dell’”Albuquerque”, i loro drammatici racconti, l’ansiosa “conta” la fraterna assistenza dei marinai portoghesi e, finalmente, lo sbarco sulla rada di Lorenzo Marques.
A bordo dell’”Albuquerque”
30 novembre 1942: ore 6,00
L’alba dopo una notte insonne. L’oceano è increspato, nel cielo mille boccoli rosati. A mezzo miglio ballonzolano tre zatteroni. Ieri sera, dopo aver indossato una tuta unta di grasso, sono andato a cercare i miei compagni di sventura. Ci siamo contati: 31 italiani e una ventina degli altri. Lo sgomento era nei nostri cuori. Nessuno ha toccato cibo; abbiamo vuotato non so quante pentole di caffè e tè. I portoghesi hanno fatto l’impossibile; a tutti hanno dato un indumento, ci hanno medicati, hanno tentato di tirarci su di morale con la grappa; ci hanno ceduto le loro cuccette. Ma nessuno si è coricato; siamo rimasti in coperta, sferzati dal vento, incuranti del freddo, gli occhi sbarrati sull’oceano.
Un ufficiale ci aveva detto degli zatteroni avvistati quando ormai era scuro. Li hanno tenuti sotto sorveglianza, illuminandoli a tratti con una fotoelettrica.
Ore 6,30
Due lance a motore sono state calate e si dirigono verso gli zatteroni. Sulle coffe, sui punti più alti del caccia sono sparpagliati i trenta guardiamarina che compiono l’ultimo viaggio di istruzione prima di prendere l’imbarco. Scrutano l’oceano con i cannocchiali. Ogni tanto si sentono delle grida: hanno avvistato qualcosa.
Ore 7,00
Torna una delle lance; un’altra ventina di naufraghi è a bordo. Ne riconosco alcuni: Carcasci, Tesconi, Freschi, Giusti, Giuseppe Lombardi, il mio conterraneo Mario Andreoli.
Ore 7,30
Vengo accompagnato dal comandante della nave, capitano di vascello Josè Guerriero de Brito, che mi ha fatto chiamare. Per prima cosa mi riveste da capo a piedi. Poi mi narra del nostro salvataggio. Quando il comandante dell’U Boat lanciò l’S.O.S. in cifrario per non essere localizzato (e l’appello dalla Germania fu ritrasmesso a Lisbona) l’”Afonso de Albuquerque” stava entrando nella baia di Delagoa, al termine del lungo periplo africano. L’ordine da lui ricevuto era perentorio: invertire subito la rotta, raggiungere il punto del naufragio, portare a Lorenzo Marques i superstiti.
Da mezzogiorno di ieri, il comandante de Brito sta rastrellando l’oceano con metodo scientifico. Su una carta nautica ha tracciato un rettangolo largo 5 miglia e lungo un centinaio: fa la spola in continuazione dall’uno all’altro dei lati maggiori. Solo così può avere la certezza di salvare chi è ancora vivo.
Sopraggiunge il vicecomandante, capitano di corvetta Flavio de Oliveira e Souza. Porta notizie confortanti: dai tre zatteroni e da altri relitti sono stati recuperati 65 italiani e 38 britannici. In totale 96 dei nostri: sono delle briciole. Le ricerche continuano, per trovare soprattutto un quarto zatterone.
Ore 10,00
L’”Albuquerque” non ha più un posto libero. Trovo naufraghi dappertutto. Ci si abbraccia: anche con coloro che fino a ieri erano i nostri custodi. M’imbatto in De Pizziol; è concitato: “il pittore è salvo… - grida - è giù…”. Corro sottocoperta e trovo Lorenzo Bucci, l’amico carissimo, steso sul pavimento della mensa sottufficiali. E’ sfinito. Non ha quasi più voce. Gli fanno inghiottire caffè caldo e aguardiente. Mi inginocchio accanto a lui. Bucci è un paesaggista, molto efficace nel colore; ma pennelli e tavolozza non lo hanno salvato dalla deportazione. E’ avvolto in una coperta. Lentamente riprende forza. Si guarda attorno e scruta i volti dei presenti. Nel suo sguardo leggo la stessa angoscia che è nel mio cuore.
“ In quanti siamo di noi?”, chiede. “ Un centinaio circa…”, rispondo. “ Caldiron… il professor Caridi, Mario Tinti, Griffi…Mario Barbieri?...”. Ad ogni nome scuoto la testa.
“ Povero Caldiron… - mormora. - Gli dissi di buttarsi in acqua, non ne volle sapere: “cosa vuole, mi rispose, è la volontà del Signore…”. “ Era il suo destino come di tutti gli altri – replico. – Noi invece dovevamo salvarci…”. “ Io debbo ringraziare Edward – aggiunge subito – uno dei timonieri del “Nova Scotia””. Eravamo in otto, con lui. Ci siamo salvati in quattro. Eccolo là, è un colosso. Il timoniere è in piedi in un angolo; con la testa raggiunge quasi il soffitto; il suo torace è enorme. Anni addietro ha navigato su una nostra “carretta” e parla uno stentato italiano. “noi, non morti su croce…” dice, addentando una pagnotta.
Bucci s’è rianimato; si tira su, appoggiandosi con le spalle ad una colonnina. “ Quel demonio – esclama – non so dove ha trovato tanta energia. Eravamo in quattro aggrappati ad una tavola, quando sopraggiunse lui a nuoto rimorchiandone un’altra. Tirò fuori il coltello. Credemmo ci volesse ammazzare ed invece ci chiese le cinghie dei pantaloni. “ Legare… legare…”, urlava. Prese le due travi, le mise in croce, poi cominciò a legarle con le cinghie. Si sarà tuffato una decina di volte; risaliva e stringeva, scompariva di nuovo e serrava le due tavole. In pochi minuti la nostra “croce” fu pronta, ed ha tenuto fino in fondo. Intanto erano giunti altri tre: ci ha allora distribuito sulle quattro braccia, per equilibrare il peso…”.
Edward ascolta annuendo, mentre si scola un barattolo di birra.
“ Loro una trave morire… - dice. – Io una trave morire… legare travi, noi vivi…”. “ Durante la prima notte – continua Bucci – quattro di noi se ne sono andati uno alla volta, in silenzio…”. “ Troppi morti, porca guerra…”. Sbotta Edward.
“ Ormai non speravo più – sussurra il pittore – Pensavo di morire anch’io su quella croce…”. “ Ed invece continuerai a imbrattar tele…”, esclama De Pizziol. Ridiamo. E’ la prima volta dopo tante ore d’incubo.
Ore 12,00
Hanno salvato “Pascà”, un marittimo del “Mazzini”. Era seduto a poppa di una lancia semiaffondata. Per 53 ore è rimasto in quella posizione, senza muoversi, solo. Viene issato a bordo; cade in ginocchio, si curva e bacia la tolda. Poi sviene.
Ore 12,30
Il rancio, ma pochi ne approfittano. Siamo in molti ad avere la gola bruciata dalla nafta. Non riusciamo ad inghiottire. Con il comandante Vagliani, l’ingegnere Moffa, Adone Cuscini e il giovane Mancuso ne approffitiamo per una ennesima “conta”. Stendiamo un elenco: siamo in 103. ma manca sempre uno zatterone. Non si sa dove si sia cacciato.
Ore 13,30
Da un’ora navighiamo a tutta velocità. Il mare s’è ingrossato: bisogna trovare lo zatterone, prima che sia troppo tardi. Finalmente viene avvistato a babordo.
Ore 13,45
Gli ultimi superstiti mettono piede a bordo: 16 italiani e un sudafricano. Uno dei nostri, un carabiniere siciliano, è privo di sensi. Un pescecane gli ha asportato il calcagno sinistro. E’ esangue. Con degli stracci gli hanno serrato la gamba al di sopra della caviglia. Il piede è gonfio, la ferita orribile. E’ gravissimo. Tra gli ultimi è anche Ignazio Cimino, palermitano, vecchio compagno di prigionia, fuggito non so quante volte e ripreso proprio alla vigilia della partenza.
Ore 14,00
I pescecani, ecco un nuovo argomento che si insinua nei racconti. Cosa stranissima, noi degli zatterini non ne abbiamo visti. Hanno invece seguito le grosse zattere. Le hanno anche attaccate. Il racconto di Cimino è impressionante.
“ Quando avvenne il siluramento, – narra – ero in coperta, vicino all’ingresso della stiva-dormitorio. L’esplosione mi scaraventò sul fondo. Mi rialzai illeso, ma attorno a me erano in parecchi i feriti gravi che urlavano. Feci in tempo a risalire di corsa la scala che questa crollò. Stavano lanciando uno zatterone: mi tuffai e fui il primo a salirvi sopra. Altri mi raggiunsero. Presi un remo e li incitai a vogare con me per allontanarci dalla nave che stava affondando rapidamente.
Facemmo appena in tempo; quando il “Nova Scotia” s’inabissò, sentimmo uno strattone; per un’istante la zattera vorticò, ma resistette. A dieci metri da noi una lancia carica di inglesi e due piccole zattere furono risucchiate dal gorgo. Sparirono.
“ Eravamo in 17 – continua Ignazio e intorno tutti lo ascoltano trattenendo il fiato – quando ci raggiunse il carabiniere; l’acqua era limpida e la vedemmo in trasparenza rossa di sangue. Uno squalo lo aveva addentato al piede. Lo issammo, stracciammo una camicia e gli legammo la gamba per arrestare l’emorragia. Poi lo mettemmo al centro, seduto, con il piede in acqua. Era l’unico disinfettante che avevamo. Fu forse per quel sangue che subito dall’inizio fummo seguiti dai pescecani. Ci sfrecciavano intorno; vedevamo le loro pinne triangolari e quelle orribili bocche quando si rivoltavano. Ma per tutto il 28 e 29 non ci diedero fastidio. All’alba del 30 ci accorgemmo che uno di noi, un professore di matematica dell’Asmara, era morto durante la notte. Da un giorno tremava e si lamentava debolmente. Che potevamo fare? Gli frugammo nella giacca per sapere come si chiamava, perché lo si conosceva solo come “il professore”. Non aveva nessun documento. Allora decidemmo di buttarlo in acqua.
“ Dio che scempio – Cimino si copre con le mani gli occhi ed è scosso dai singhiozzi. – L’acqua si arrossò, spumeggiando, percossa da quei corpi verdastri. Quanti erano? Fu l’inizio della battaglia. Guizzavano da ogni parte, addentavano i bordi della zattera, molto bassa dato il carico, s’incuneavano sotto tentando di rovesciarla. Demmo di piglio ai remi e cominciammo a battere.
Non avevamo altro. Un remo si spezzò nelle fauci di uno di quei mostri. Ci tenevamo avvinghiati l’uno all’altro per paura di cadere in acqua. Ogni tanto smettevano, poi tornavano alla carica. E noi a battere, disperatamente. Si è andati avanti così fino a quando sono arrivate le lance; anche i portoghesi hanno dovuto difendersi”.
Ore 16,00
La “conta” è definitivamente chiusa. Ci siamo salvati in 119; i britannici sono 64. c’è anche il tenente Gallard, quello della “Donna è mobile…”. Lo trovo seduto accanto ad un boccaporto. Si congratula con me; poi con flemma mi dice: “ Mi faccia avere un elenco completo degli italiani salvati e tenetevi pronti perché ci stanno portando a Durban. Lei mi risponderà per tutti…”. “ Un corno! – rispondo – qui comandano i portoghesi. Il capitano de Brito m’ha detto di aver ricevuto l’ordine di portarci a Lorenzo Marques…”. “ Voi siete prigionieri di guerra – insiste il rhodesiano – e sono io che do gli ordini a voi…”.
A stento, Vagliani e io, riusciamo a frenare la voglia matta di alcuni dei nostri di dargli una lezione. Giungono anche degli ufficiali portoghesi. Poco dopo il comandante de Brito ci rassicura. Vi debbo portare a Lorenzo Marques dove sbarcherete. E’ vero, da Durban, per radio mi hanno ordinato di portarvi là. Ma noi siamo neutrali. L’”Albuquerque” è terra portoghese e qui vigono le nostre leggi, soprattutto quelle dell’onore e del cuore…”.
Ore 17,00
L’oceano ribolle. Le onde spazzano la coperta. L’acqua e i medicinali scarseggiano. Non si può più sperare. L’”Albuquerque” drizza la prora a nord, verso Lorenzo Marques. Abbiamo il cuore in una morsa. Addio, compagni diletti, amici di prigionia e di sventura. Per voi è una sola, immensa lastra oceanica. Domani noi sbarcheremo in un porto sconosciuto; ricominceremo a vivere; conosceremo altre genti, forse impareremo un’altra lingua. Un giorno questa maledetta guerra finirà, torneremo nelle nostre case.
Gli anni voleranno via: e tante voci, tanti volti si veleranno della nebbia del tempo. Ma di voi, fratelli più sfortunati, non ci scorderemo mai. Voi continuerete a vivere in noi, vivrete nei nostri figli ai quali un giorno narrando di voi, del vostro sacrificio, potremo ripetere col Poeta: “ Chi per la Patria muore, vissuto è assai”.
Carlo Dominione
Il racconto di un altro sopravvissuto pubblicato sul “Il Tempo” n. 5 del 31 gennaio 1953.
Sul rottame fatto a croce quattro naufraghi volevano lasciarsi morire
È l’alba. Navighiamo da dodici giorni in un mare mosso, ma sicuro da ogni insidia. Soltanto ieri ho notato una certa inquietudine fra l’equipaggio e i sudafricani; verso sera hanno persino eseguito una prova d’allarme. Ho chiesto il perché dell’agitazione. “Andiamo verso il cimitero delle navi. Tutte a picco, davanti a Lourenco Marques”. Un gruppo di sommergibili tedeschi, che gli inglesi non sono mai riusciti a localizzare, terrorizza queste acque. Da due notti siamo autorizzati a dormire sopracoperta. Si viaggia a luci spente e chi tenta di accendere una sigaretta rischia di ricevere una fucilata dai soldati di guardia.
Piove da oltre una settimana; i nostri vestiti sono fradici. È sempre l’alba. Accanto a me un soldato sudafricano scherza con la bambina che abbiamo a bordo. La solleva, la sporge fuori dalla nave: “Ti butto, ti butto”. La piccola urla, agita le gambe, piange di paura. Sono le 6,07: un colpo sordo, tremendo, al centro della nave. La “Nova Scotia” ha un sussulto, trema sotto il tritolo del siluro tedesco, si piega a destra, si raddrizza, cede sulla sinistra, si raddrizza di nuovo e prosegue per inerzia, per altri duecento metri, col centro fracassato.
In uno spaventoso minuto ho conosciuto la paura, la disperazione, la pazzia, la rassegnazione, la vita, la morte. Con gli altri sono stato gettato più volte contro i parapetti della nave. Grida si levano tra il densissimo fumo, il fuoco ci impedisce di vederci l’un l’altro. Come ho fatto a trovare la scaletta che porta alla parte superiore, riservata agli ufficiali inglesi e sudafricani? Sull’ultimo gradino mi fermo di colpo. A gambe larghe, con la pistola spianata, il comandante della nave spara contro tutti coloro che stanno tentando di raggiungere la lancia di salvataggio riservata agli ufficiali inglesi. Un solo italiano è riuscito a sistemarsi: lo riconosco, è il dottor Cariddi, direttore della maternità dell’Asmara. Mi vede, mi chiama. Ma la pistola del capitano mi fa troppa paura. Scendo nuovamente la scala, torno nell’inferno.
Dopo un minuto riesco a salire in coperta. Mi urtano, mi passano a fianco urlando, maledicendo. Qualcuno si è già buttato in acqua, un soldato dall’alto si sta calando attraverso un tubo di scarico. Vedo il fianco della nave e l’uomo che scende verso il mare che brucia. Grappoli umani si agitano intorno a uno zatterone, riescono a staccarlo, precipitano in acqua con lui, ma la corsa trova un ostacolo: il soldato che sta scivolando lungo il tubo. Un’asse dello zatterone gli stacca la testa; il corpo resiste qualche secondo, poi si rovescia, inghiottito dall’oceano.
La nave sta percorrendo gli ultimi metri. Mi lancio; toccando l’acqua il salvagente mi colpisce la mascella quasi stordendomi. Fiammelle viola punteggiano l’acqua che, a causa della nafta, si è fatta tranquilla. La nave, a pochi metri, si sta fermando, brulicante di gente che urla, che corre senza meta, che ha paura di lanciarsi, già condannata a morire assieme. Su un boccaporto, a malapena, distinguo il dottor Caldiron, un veneto, direttore di un’agenzia commerciale dell’Asmara. “ Dottore, per carità, venga giù, si butti ”. “ Cossa volo, xe la volontà del Signor! ”. Allarga le braccia, alza la testa. Quando eravamo partiti da Massaua mi aveva detto: “ Questo è l’ultimo viaggio. Moriremo tutti. Lo sento che moriremo tutti. Xe l’ultimo “. Quelle parole mi tolgono, quasi, la forza di reagire. Volto il capo e annaspando tra le fiammelle viola, cerco di allontanarmi il più possibile dalla nave. Attorno a me, centinaia di teste appaiono e scompaiono, dirette alle quattro o cinque zattere che avevano potuto essere staccate dalla “Nova Scotia”. Ma chi arriva per primo non vuole che altri, aggrappandosi, metta a repentaglio la sua vita. Più volte il remo di un marinaio si abbatte su quelle teste. L’istinto di conservazione è una forza bruta. Meno carica è una zattera e maggiori sono, per chi la occupa, le probabilità di salvarsi. Ecco, ora sono passati cinque minuti, tutti gridano. Insieme. La “Nova Scotia” si sta inabissando. La poppa si alza; centinaia di nere formiche si addensano attorno alle eliche. Vicino c’è una lancia degli ufficiali inglesi: scompare la poppa della nave, la segue anche la lancia, verso gli abissi. Qualcuno si è dimenticato di staccare il cavo.
L’oceano è immenso. Mi sento esausto, ma non voglio morire a colpi di remo. Cerco, con gli altri, un rottame. Ma perché gridano ancora? Una sagoma nera è uscita dall’acqua: il sottomarino tedesco. Escono tre uomini e corrono alle mitragliere. Dieci, cento cinquecento bocche gridano che siamo italiani, che siamo prigionieri. Viene lanciato un cavo al quale si aggrappano due naufraghi.
Salgono a bordo. Noi, in acqua, tremanti dal freddo, attendiamo. Poco dopo ecco il comandante. È un ufficiale giovane con una lunga barba nera. Parla attraverso il megafono in italiano stentato: “Perdonatemi. Io non ho affondato i prigionieri, ho sparato contro una nave inglese. Perdonatemi. Non posso aiutarvi. Ma non vi abbandono: avvertirò i portoghesi. Fatevi coraggio, resistete”. Poi un comando in tedesco e i quattro rientrano. Il sommergibile si inabissa. Non lo rivedremo più.
Che ore saranno? Da questo momento per sessanta ore, ogni minuto mi porrò la stessa domanda. Sessanta ore. Il mio orologio è fermo alle 6,07: quando la nave ha ricevuto il siluro devo aver picchiato contro qualcosa e il vetro si è rotto. Batterò coi denti, per il freddo, ogni minuto delle sessanta ore. Il mio salvagente sta afflosciandosi; annaspo verso una grossa asse attorno alla quale sono aggrappati dodici o tredici italiani. C’è un posto anche per me su quel relitto di nave lungo un metro, largo sessanta centimetri, alto trenta. Posso guardarmi un poco: nero di olio; coperto da un paio di pantaloncini e dalla giacca di un pigiama. Non conosco nessuno dei miei compagni. Attorno su altri relitti forse cinquecento persone galleggiano in mezzo chilometro.
I pescecani! Sono arrivati verso sera. File di pinne passano a poca distanza. Accanto a me un giovanotto bruno grida, poi scompare inghiottito. Sale subito dopo una macchia rossa. In silenzio ci guardiamo, ognuno sperando che sia l’altro, la prossima vittima. Per cinque, sei volte la morte arriva ad alleggerire il carico del rottame. Quando più tardi, ci contiamo siamo in otto. Il mare è rosso.
Anche il giorno ormai sta per morire. Arriva verso di noi un uomo seduto sull’acqua. È un siciliano che ha trovato un’ asse e si è messo sopra. Dietro, col busto fuori, un altro rema con le braccia. È un sudafricano, uno dei due timonieri della “Nova Scotia”, un ragazzo enorme. Ci raggiunge: “Legare, legare insieme due legni. Altrimenti annegare tutti. Fare croce. Mare grosso, ora. Affogare se non unire due legni”. Il siciliano scende dal rottame. Siamo nove italiani e un “nemico”. Il sudafricano sfila un grosso coltello. Capisce d’averci fatto paura e dice: “Io non volere uccidere. Volere salvare anche voi. Aiutarmi”.
Ma dove ha preso tanta energia? Si tuffa, riaffiora, passa da uno all’altro, esegue con rapidità l’operazione, annoda le cinghie, riunisce i due rottami a croce. Li lega, si rituffa, riappare, scompare di nuovo, sembra proprio un delfino. Noi, quasi assenti, seguiamo le sue mosse. Alla fine il relitto tiene il mare con maggior stabilità. Il giovane timoniere sudafricano sorride contento.
La notte e tante stelle sull’oceano. Alcuni zatteroni, all’orizzonte, illuminati dalle torce a sfregamento testimoniano che altri, con noi, stanno lottando contro il tempo, contro la morte, contro il freddo, contro la voglia di finirla. Di notte si tace. Soltanto il ritmo dei nostri denti che battono per il freddo. Uno dice di avere bisogno di riposare. Lo issiamo sul relitto ma un’onda, poco dopo, se lo porta via e non grida nemmeno. Più tardi un altro chiede di salire. Si terrà stretto, dice. Resisterà. Se restasse in acqua, dice, si lascerebbe andare tra poco. Resta sul relitto forse mezz’ora: un’onda arriva, lunghissima e lo risucchia.
Siamo rimasti di nuovo in otto. Com’è interminabile la notte. Le luci delle zattere si fanno sempre più piccole. Molti altri relitti sono scomparsi, portati via dalle onde coi loro carichi di superstiti.
È ancora l’alba. Il sudafricano vuole ospitarci a casa sua, quando sbarcheremo. I tedeschi hanno promesso di salvarci ma lui dice che sono più in pericolo di noi. Verranno i portoghesi? Le nostre gambe si sono fatte pesanti, le dita non hanno più la forza di sorreggerci. Ogni tanto qualcuno perde i sensi. Pronto, il sudafricano si tuffa e lo recupera. Siamo in acqua da ventiquattrore, quando si ha sete ci si butta per un attimo. Un sorso salato. Siamo in otto, ma prima di mezzogiorno ne mancheranno altri due. Sono impazziti: gridano, ci prendono a pugni, ci mordono. Vogliono essere salvati, vogliono ucciderci perché non li salviamo, “perché li vogliamo far morire”. Uno alla volta si staccano dal relitto.
“Vai a salvarli” urliamo al sudafricano, ma lui scuote la testa. “Lasciare morire. Meglio morire subito”. Due uomini se ne vanno nell’oceano. Chi erano? Siamo rimasti in sei. Mi domando se sarò io la prossima vittima di questa estenuante attesa. Ci guardiamo battendo sempre i denti. E ognuno incomincia a raccontare la propria vita, a far conoscere agli altri cinque i propri figli, la propria moglie, il proprio paese. Gelo in acqua, caldo tremendo sul capo. Il sole di mezzogiorno, il sole d’Africa picchia sulla testa. Ogni tanto, un tuffo. Sotto le membra rattrappite dal freddo.
I pesciolini maledetti. Migliaia, milioni di pesciolini, sotto di noi, come spilli. Si attaccano alla pelle, succhiano. In tutto il corpo un tremendo, insopportabile prurito. E poi le meduse. Arrivano con le loro lunghe code che si avvinghiano alle gambe. Il coltello del sudafricano lavora, per ore, attorno alle nostre gambe: dove si è fermato il braccio della medusa rimane un segno bluastro che dà bruciore. Poi le meduse se ne vanno.
Siamo stati dimenticati dal mondo. Due miliardi di uomini, mormora il sudafricano, non sanno salvare sei naufraghi. Il “nemico” ci spiega perché, il giorno prima, non eravamo stati uccisi dai pescicani: “Voi coperti di nafta. Non cibo prelibato”. E ride vedendoci, per un momento, distratti.
Quando è sera per la seconda volta uno dice che dobbiamo morire tutti insieme come fratelli. “Lasciamo il legno, abbracciamoci e che sia finita. Perché ritardare la morte? Perché resistere inutilmente?”. Ma il sudafricano grida: “A destra, una nave!” è un cacciatorpediniere inglese. Siamo salvi. Salvi. Urliamo. Il sudafricano mi strappa una manica del pigiama, la agita. La nave è vicinissima: ai parapetti si vedono allineati i marinai. Ecco, ora la nave è ferma. Ci caricherà, penso. I marinai ci indicano fra di loro… Le eliche, vorticando, fanno quasi capovolgere il relitto. Stiamo per affondare. Chiudo gli occhi e mi aggrappo con tutte le forze. Quando li riapro, la nave è lontana. Non si sono fermati, hanno proseguito la corsa verso un porto sicuro. Ci hanno lasciti ancora soli in mezzo al mare. Nell’aria si perdono gli ultimi, tremendi insulti del sudafricano.
“Adesso muoio. Me ne vado; non ce la faccio più. Sono sicuro di andare in paradiso. Se tornate in Italia salutate i miei figli, ma non dite che ho sofferto così tanto.” È il bolognese, quello che, ieri sera, voleva che morissimo tutti insieme. Calmo, quasi staccato ormai ci parla di un viaggio che compirà da solo. “Ora mi stacco”. Resisterà invece tutta la notte. All’alba, si lascerà andare dopo averci salutati tutti, uno per uno, tranquillamente.
È la seconda notte in acqua. Nessuna luce, ora, all’orizzonte. Dove sono le zattere? Dove sono gli altri? Tutti morti? Tutti salvi? Dove siamo noi? Lontani, vicini alla costa? Perché resistiamo? Perché continuiamo a rimanere aggrappati a queste due assi? “Questa è la nostra croce”. Aveva detto il bolognese. “Moriamo come Gesù”. E parlava del paradiso guardando le assi incrociate del relitto. Cerco di non pensare a nulla. Alle prime luci della terza alba, quando il bolognese si stacca dal relitto va verso la morte quasi sorridendo, ci accorgiamo che un altro, veneto, credo, si è abbandonato con il capo contro il legno. Il siciliano lo scuote: “Svegliati. Non è il posto più adatto per dormire. Ehi!”. L’altro non risponde. Il sudafricano si avvicina, lo guarda, gli apre le palpebre. “Morto” dice. Siamo rimasti in quattro. Il morto ha le dita incastrate nel legno. Occorre staccarlo ma non si riesce. Ci sforziamo ma le dita resistono: si sono inserite nella spaccatura dell’asse, si sono gonfiate. “Voltatevi” grida il sudafricano, ma i nostri occhi guardano quelle dita bianche e stecchite. A un tratto luccica il coltello del sudafricano. Uno, due, tre, quattro colpi. Il morto si stacca, affonda. Gli inglesi ci rivolevano
A mezzogiorno mi sono confessato. I miei compagni, il siciliano, un genovese e il sudafricano, non parlano. Si sentono sempre i denti battere. C’è un silenzio tremendo. Siamo ormai rassegnati. Mi sono confessato. I miei tre compagni hanno ascoltato, o forse non hanno ascoltato, le mie confessioni. Ci guardiamo con compassione; nessuno ha però il coraggio di proporre per primo quello che ognuno ha nella mente. Lasciarci morire. Alle sette del mattino avevamo visto un’ aereo e il fumo di una nave, ma entrambi erano scomparsi subito. Bisognava proprio lasciarci morire.
Il sole è ancora a picco sulle nostre teste, dev’essere già passato mezzogiorno. Che cosa aspettiamo? Perché aspettiamo? “Avion! Avion! Avion!” urla il sudafricano. Ma dove li sente o li vede questi aerei? È impazzito anche lui. Lo guardiamo e gli mostriamo i denti. “Denti! Denti! Denti!”. Gli vogliamo far capire che il rumore che sente è quello dei nostri denti che battono.
Una sagoma nera appare a un centinaio di metri di distanza. È una nave che si dirige verso di noi. E allora tutti e quattro ci buttiamo, impazziti, sopra il relitto a croce. Rimaniamo miracolosamente in bilico. Urliamo, piangiamo, ci abbracciamo. Ma dove erano nascoste le forze che ci sorreggono ora? La nave è vicina: cala una lancia. Siamo salvi. Ho baciato fino a svenire la barba di un marinaio portoghese che mi sollevava per le ascelle. Gonfio d’acqua, sfibrato, sento, infine, il duro legno della tolda della nave. Non so pensare a nulla.
Qualcuno mi fa bere mezzo litro di grappa. Quando mi sveglio, forse dieci ore dopo, c’è sulla mia testa quella del capitano: “Gli inglesi volevano che vi consegnassi a loro. Ho risposto che il pescatore sono io e che i pesci li porto a casa mia”.
Siamo gli ultimi quattro dei centodiciannove italiani e diciannove sudafricani salvati dalla nave portoghese Afonso de Albuquerque che da due giorni ci stava cercando a 162 miglia dalla costa.
Lorenzo Bucci
Dott. Ing. Vitale MOFFA
“LA MIA GUERRA”
ROMA
10 marzo 1990
Il 28 novembre 1942, all’uscita del Canale del Mozambico, venne affondata, da un sottomarino tedesco la nave ausiliaria “Nova Scotia”, che trasportava militari sud africani, di rientro dal Nord Africa e settecentosessantotto italiani, con la qualifica di prigionieri civili, raccolti in più retate fatte in Eritrea, con lo scopo di sfollare la città dell’Asmara e procurare mano d’opera nelle colonie inglesi della Rodesia.
Degli italiani, circa trecento erano marittimi di navi affondate nel porto di Massaua ed il rimanente cittadini italiani residenti in A. O. I. per lavoro privato e per lo Stato.
I superstiti italiani salvati dal naufragio furono 122, di cui 119 raccolti dalla nave scuola portoghese “Alfonso de Albuquerque” di stanza a Lorenco Marques, ora Maputo, due raccolti dal sottomarino tedesco ed uno che, stremato di forze, fu raccolto, dopo una settimana sulla spiaggia del Natal.
Fu una grande perdita perché con l’affondamento perirono circa 200 italiani laureati: medici, ingegneri, architetti e dottori vari, che in A. O. i: si erano trasferiti per esercitare la propria professione.
Il sottoscritto infatti, era stato assunto dalla Italstrade ed addetto ai lavori del tronco Dussiè-Assab.
Appena a terra, ancora sotto l’impressionante spettacolo, penso di fermare, con questo racconto, le immagini della tragedia che distrusse tante vite; tragedia che poteva essere evitata con qualche segnale della Croce Rossa.
Questo racconto fu pubblicato sul 1° numero della rivista “AZZURRO”, che viene stampata in Sud Africa nella doppia lingua.
Credo di poter dare, con l’invio di una copia, il suo contributo, onorando così la memoria di tante vite distrutte.
Firmato: Vitale Moffa
Dalla documentazione conservata nel Fondo Rai – La mia guerra, fasc. 4266
La tragedia della “Nova Scotia” nel racconto di un sopravvissuto
Di Vitale Moffa
La seconda guerra mondiale. Per alcuni fu subito un tragico errore. Per molti soltanto una generosa illusione, nella convinzione di servire la Patria.
Comunque, una serie di pagine dolorose legate insieme dal filo del destino. Un destino beffardo e crudele, come nel caso della “Nova Scotia”. Il comandante del sommergibile tedesco, che prima saluta sul ponte la nave che affonda, fiero del suo successo, e pochi attimi dopo si dispera perché realizza di aver condannato al naufragio degli alleati prigionieri; è emblematico di come la volontà e l’eroismo degli uomini siano poca cosa contro i tiri della sorte.
Presentiamo questo documento di un sopravvissuto come testimonianza di vicende che non si possono e non si devono dimenticare. L’abbiamo di proposito voluto lasciare così com’è stato scritto allora: con i suoi anacronismi e, forse, anche con un pizzico di retorica d’altri tempi, ma traboccante della bellezza di sentimenti puri e sinceri a confronto con una prova delle più dure.
Di mese in mese, vivendo con il sussidio che ci arriva da qualche parte, ma che nessuno vuole legalizzare per paura di un domani difficile, con le nostre preoccupazioni diarie, siamo arrivati in attivamente alla prima decade di novembre.
Quello che più ci impressiona e più ci preoccupa sono le retate, di cui noi civili siamo stati finora immuni. Da qualche giorno, infatti, si parla di una retata generale. Gli alleati hanno bisogno di evacuare gente dall’Eritrea per alleggerire la sorveglianza e per far posto ai loro evacuati dall’Egitto.
Approfittando di navi che rientrano scariche dal nord Africa, dove hanno depositato il loro carico prezioso di uomini e materiale, viene organizzato lo sfollamento. Si raccolgono uomini dappertutto; per strada, in casa, di notte, in qualsiasi ora del giorno. Quello che a loro interessa è liberare la città di persone a loro inutili.
I camions carichi vengono indirizzati ai campi di concentramento ed all’ora dei pasti ci si trasferisce da un campo all’altro. Si dorme dove capita, naturalmente, per terra con la testa sulla valigia. Sballottati dappertutto, si arriva al campo di raccolta di Decamerè. Lì si ha l’impressione che siamo degli indesiderabili; nessuno, infatti, ci vuole ricevere. Dietro le nostre proteste e dopo esserci abbrustoliti all’ultimo sole eritreo, ci fanno entrare in un capannone, dove, ancora protestando, ci danno qualcosa da mettere finalmente in bocca.
Dovrebbe essere una zuppa di carne, ma di carne non c’è nemmeno l’ombra.
Nel campo eritreo c’è un gran daffare per catalogarci: si diventa un numero. Per pochi giorni siamo ospiti del campo, quanto basta per non poterci organizzare come i nostri che ci hanno preceduti. Giungono altri e ciò serve per rompere la monotonia di quei giorni.
Operai e professionisti vivono la loro vita in comune e questo fatto porta qualcuno alla conclusione che siamo tutti uguali. Qualcuno tende a dimostrare la propria superiorità. Hanno però ragione i primi; infatti, non si fa distinzione di casta e di credo e la vita è uguale per tutti.
Nei giorni 14 e 15 di novembre si capisce che la partenza è prossima. Movimento insolito, chiamate per fotografie e per dare le proprie generalità. Molti sono con nome falso, sperando in una possibilità di salvarsi dal peggio. E’ inutile, non sanno quello che li aspetta e potranno diventare dispersi. Il 16 mattina si parte da Decamerè. Siamo collocati su camions e su ognuno vengono fatte salire quattro sentinelle armate. Siamo ben guardati e non resta altro che chiudersi in se stessi e pensare ai propri familiari, alla propria attività che resta sospesa, alla nuova avventura che ci aspetta. Rivedremo di nuovo l’Eritrea? Torneremo o ci perderemo per strada? In mezzo a questo turbinio di idee, i camions rombano sotto ilo sole sulla strada Decamerè-Massaua. Nel mentre si gira un film; la pellicola rimarrà nella storia, alcuni di noi la potremo vedere, altri non la vedranno. Da lontano saremo una folla che si sposta, gli alleati diranno quello che vogliono, perché per loro siamo solo dei numeri, tanti capi da trasportare, secondo loro, in Rhodesia.
A Massaua ci si unisce al gruppo che arriva da Asmara e a quello prelevato sul posto. Ci contano: uno, due, tre, …cento,…duecento,…settecentosessantotto.
Qualcuno arriva in ritardo per riempire qualche posto vuoto. Movimento insolito, pare che uno si sia buttato in mare, pensando forse ad una disperata fuga. E’ ripescato e viene messo in gabbia, forse morirà lì chiuso, forse si salverà, nessuno sa niente, perché da questo momento quello che ad ognuno interessa è il proprio io.
Le idee si affollano nella mente di ognuno, si accavallano in una danza fantastica. L’ultimo pensiero, però, è per quel lembo di terra Eritrea che era nostro fino a qualche anno fa e che ora si allontana con tutti i nostri ricordi, i nostri sudori.
Massaua, che con la sua banchina brulicante di gente e zeppa di viveri ci aveva accolti festosamente qualche anno addietro, adesso è muta e forse, anche lei come noi, pensa al suo triste destino.
Massaua…, tu che come vedetta ci venisti incontro al nostro arrivo, tu che avevi dietro di te una terra piena di braccia italiane in lavoro continuo, ti dobbiamo lasciare, ci portano via e nessuno sa se un giorno ritornerà.
Terra d’Africa…Nostra Africa…, quanti ricordi e quanti sudori… Ti salutiamo tutti, andiamo via, ma il nostro cuore è con te.
Sulla “Nova Scotia”
Sulla “Nova Scotia” ci si sistema subito, i nostri bagagli sono pochi, qualcuno non ne ha, è a torso nudo e va cercando qualche camicia da amici, perché, preso sul lavoro, non ha potuto recarsi a casa per fornirsi di un po’ di roba personale. Uno sguardo alla nave per la presentazione. E’ una nave pista di 16 mila tonnellate, la cui vernice grigia di guerra nasconde l’età. A poppa c’è il solito cannone con il solito guardiano che la nostra fantasia chiama “Capitan Cocoricò”.
Eppure, in tanta desolazione, queste cose ci divertono. Siamo stivati ed il nostro giaciglio è sotto il tavolo; qualcuno ha trovato il deposito delle amache marinare e se ne impadronisce perché pensa che potrà dormire meglio. L’illusione dura pochissimo, perché, scoperto, è costretto a restituire tutto. Qualcuno lavora in cucina, si adatta a fare il cameriere, il fornaio, o l’attendente di qualche ufficiale. Unico scopo è di poter trovare qualcosa da mangiare nei rifiuti delle pietanze. Il nostro rancio sa solo di grasso, carote, patate, patate e carote lessate.
Ci presentiamo. Siamo noi: un duecento laureati, un quattrocento marittimi scampati alla furia della guerra che affondò le navi a Massaua, professionisti, commercianti e operai.
Di sera ci si proibisce di fumare in coperta e nella stiva non si può per via della respirazione che diventa difficoltosa. Ci guida un capitano rhodesiano che è sempre ubriaco, mentre a nostro contatto diretto sta un tenente, anch’egli rhodesiano, ex impiegato di banca, che forse da borghese passava la vita a riempire moduli ed ora, con una grandissima responsabilità, è diventato facilmente irritabile.
Sulla nave, oltre a noi, si trovano circa trecento soldati sudafricani che, mezzo fracassati dalla guerra del deserto, se ne ritornano a casa per riposare un po’.
Nei loro occhi vi è un po’ di amarezza in conseguenza delle ultime vittoriose giornate del nostro schieramento, in avanzata continua. Il resto è equipaggio. In tutto, siamo circa millecentosettanta uomini.
A bordo vi sono alcune donne, mogli di ufficiali, e tra esse una di discendenza italiana, nata a Durban e moglie di un ufficiale sudafricano, morto all’Asmara.
Ritorna a casa con una bambina di 10 anni circa, dopo aver sofferto ed aver ottenuto con chi sa quali sforzi il suo premio.
La vita a bordo non si può dire sia monotona. Vi è qualche imprevisto, cosa questa che mantiene attenti. A turno facciamo il servizio di pulizia e la nostra maggiore attenzione va al pavimento, che la notte ci serve da giaciglio. Alle nove del mattino, fatta la pulizia, c’è la conta. Tutti in fila in coperta con il nostro salvagente, amico inseparabile, compagno caro nella nostra avventura. Quando non è sulle spalle, ci serve da sedile…
Ci conforta il fatto che le cose in Africa vanno discretamente e molti sognano fermamente il loro ritorno in Africa. Qualcuno pensa ancora alla vendetta che farà su colui che lo ha denunciato e si ascoltano le notizie “Radio Fante”, che di tanto in tanto giungono anche a noi, non si sa per quale strada.
I nostri carcerieri, che sanno la nostra nazionalità, ci invitano a cantare. Forse nella loro mente pensano che noi, italiani, dobbiamo essere per forza tenori o baritoni. Alla meno peggio si imbastisce un coro. Cominciano pochi e con timidezza… Si canta. Si capisce dalle prime note che è il “Coro dei Lombardi”.
Tutti lo conoscono e danno il loro contributo. Loro sono contenti e noi sfoghiamo il nostro sconforto con quel canto. Credo che nessuno di noi lo abbia mai cantato prima con tanto sentimento come in quel momento. Quel canto, che a scuola ci diceva poco o nulla, in quel momento assume un ruolo importantissimo per la nostra esistenza, e da noi è apprezzato in tutta la sua monumentalità. Credono forse di udire “O sole mio” o qualcosa d’altro? Stanno udendo un inno vibrante di italianità e lo devono applaudire.
Durante il giorno vi è un gran da fare per le vaccinazioni, che il tempo ristretto ha impedito di fare prima della partenza. Trasferimento da una stiva all’altra e questa volta non per numero, ma per nome: questo ci dà un po’ di personalità.
Nuovi amici di stiva e di tavolo. Si ritrova qualche amico vecchio, lasciato qualche giorno prima. Nuova sistemazione. Le giornate si susseguono con calma mentre la nave segue il suo corso a zig-zag. Qualcuno legge, qualcuno gioca, i più giovani vanno in cerca di mangiare e si accontentano di sbucciare patate e carote per mettere in bocca qualche carota cruda.
Giorno dietro giorno, usciamo dal canale del Mozambico. Siamo al 27 sera.
Movimento insolito, qualche nave vedetta passa e fa segnali. Contrariamente al solito, siamo chiamati in coperta per esercitazioni di salvataggio.
Il timore di una tragedia appare evidente sul viso di tutti. Si prevede qualche disgrazia. Ci si innervosisce e nessuno parla perché preferisce chiudersi nel suo guscio. Si immagina e si riflette. La notte non si dorme tranquilli. La stanchezza prende gli incoscienti, i timorosi preferiscono prendere l’umidità in coperta, e qualche goccia d’acqua.
Sono le 9 del mattino del 28 novembre. Rivista a bordo sotto un po’ di sole che ha spazzato le nuvole e la pioggia. La preoccupazione affiora sul viso degli ufficiali che ci accompagnano; noi siamo più tranquilli perché ci troviamo in coperta ed un tuffo è più facile farlo. Il silenzio e l’immobilità generale sembra che annunzino la tragedia.
Il naufragio
28 novembre – ore 9, 45. Due colpi, uno dopo l’altro, scuotono la nave. Dal fumaiolo escono fiamme miste a vapori. La nave è stata colpita in pieno nella sala macchine. Nessun panico: ognuno è consapevole di ciò che deve fare; responsabile solo delle proprie azioni, agisce indipendente dagli altri; i più paurosi si buttano in mare. La nave intanto si inclina e le fiamme l’avvolgono da prua a poppa. Non c’è più tempo da perdere. I nostri bravi marinai intanto si prodigano, diretti da qualche comandante italiano, a tagliare i cavi delle quattro scialuppe disponibili, che cascano in mare e si schiantano sulle acque; le carrucole non funzionano perché arrugginite.
E’ la volta delle zattere, che vengono gettate in mare una ad una. Ognuno, in balia di sé stesso, cerca la via migliore.
Siamo già in molti in acqua, altri sono attaccati ai parapetti in ferro, indecisi se buttarsi o no. Chi può prevedere la strada più sicura? La nave continua a galleggiare, pur ferita nel fianco, o affonda? I naufraghi saranno raccolti o verranno travolti dalle onde? Pochi istanti ancora ed un sottomarino tedesco affiora alla superficie. Ne esce un giovane ufficiale con barba fluente, ne deve essere il comandante. Altri ufficiali lo seguono e si dispongono in fila per rendere gli onori militari alla nave che affonda.
Qualche istante, una pruata e nulla più. In mezzo ad una macchia d’olio, alcuni stretti alle zattere, altri nuotando, hanno davanti agli occhi la visione degli amici che, inebetiti, privi di qualsiasi iniziativa, sono rimasti stretti stretti alle barre della nave, rifiutando di gettarsi in acqua.
Per loro la tragedia si è già conclusa; ed il loro libro già si è chiuso per sempre. Per gli altri, in mare, si apre un nuovo capitolo.
Dopo una momentanea sistemazione si grida, con una voce sola: “SIAMO ITALIANI”. Il comandante del sottomarino si mette le mani in testa e ci incoraggia a stare calmi. Due naufraghi sono raccolti a bordo. Nessuno ha saputo più niente di loro. Si saranno salvato o saranno affondati? Mentre il sottomarino si allontana, portando con sé l’ultima nostra speranza, ci preoccupiamo di acquistare un po’ di calma in mezzo a quella tragedia. L’olio intanto ci avvolge tutti con una patina spessa e sembra quasi, costringendoci a tenere le palpebre chiuse, che ci voglia impedire di vedere la tragedia. Ma la tragedia, con tutta la sua forza, è lì che si fa sentire con le grida disperate di aiuto.
Grappoli umani, aggrappati a piccole zattere o relitti, galleggiano senza speranza su un mare che di ora in ora diventa più agitato. Qualche ardito nuotatore si spinge da una zattera all’altra per trovare un posto migliore, e non si accorge che spreca energie che forse gli possono essere di immensa utilità dosandole opportunamente. Qualcuno invece se ne sta calmo all’orlo di una zattera, chiedendo solo un po’ di corda, a cui si aggrappa, galleggiando. Intanto la morte continua a raccogliere le sue vittime. Mesi di campo di concentramento, stato febbrile provocato dalle iniezioni e dalle vaccinazioni fatte pochi giorni prima, denutrizione e preoccupazioni sentimentali aiutano la strage. Ogni morto è un posto vuoto, un salvagente in più da disporre. Qualche imprecazione, qualche preghiera, una litigata e poi il silenzio.
Qualche parola ci fa capire che siamo vicini ad una persona conosciuta, che al momento si presenta ai nostri occhi, tenuti aperti con due dita, in un ammasso di olio.
Il numero si assottiglia sempre e tutti pensano che dovrà anche arrivare la propria ora.
Un apparecchio sorvola la zona della tragedia, ma poi segue il proprio cammino. Dopo si saprà che era un apparecchio della linea Durban – Madagascar.
Quantunque la stagione sia ottima, il mare mosso e la temperatura bassa, dovuta al vento costante del sud, ci fanno sentire un po’ di freddo. Si stabilisce un po’ di calma e a mano a mano che ci adattiamo al nostro stato si avvicina la notte. La preoccupazione di salvarci la pelle non ci fa pensare alla solitudine e all’abbandono, perché il soccorso deve arrivare. Siamo a 40 miglia da Durban e la nave sarebbe dovuta arrivare nel pomeriggio.
La notte si dilegua alle prime luci dell’alba. La patina oleosa che avvolge i nostri corpi ci difende dall’attacco dei pescicani, che si nutrono dei cadaveri che ci circondano. Sono dei nostri compagni meno fortunati di noi. Un altro giorno si presenta con una nuova speranza, ma intanto le fila continuano ad assottigliarsi. La strage, intensa sul principio, ora va diminuendo, attaccando i meno forti di spirito. Prima uno… poi l’altro…, poi toccherà anche a me… In questa incertezza si vive aspettando quello che ci porta il minuto successivo.
La morte di un amico non ci impressiona più. In tali momenti ciascuno vive gli ultimi istanti di un condannato a morte. Sicuri di morire, con la mente vuota, ci si astiene da qualsiasi considerazione. Abituati a veder morire persone al nostro lato, siamo diventati insensibili.
Il vento e le correnti spingono i nostri relitti da tutte le parti, sparpagliandoci; la solitudine aumenta e la speranza va perdendosi.
Verso sera qualcosa appare all’orizzonte. Sarà la nave della salvezza?... Tutti cominciano a gridare, dopo aver spalancato gli occhi incollati dall’olio; si spera che il nostro grido giunga alla nave. Saranno miglia che ci separano, ma la speranza ce la fa vedere più vicina, quasi a toccarla con le mani.
La seconda notte si avvicina, la nave si va illuminando, sembra un castello incantato. Una roccaforte in mezzo al mare, la roccaforte a cui si aggrappa il nostro desiderio di salvezza. Nessuno riposa: la tensione aumenta con il tempo.
Momenti di scoraggiamento e di speranza si alternano, perché la nave si avvicina e si allontana frequentemente.
Sarà forse la speranza della salvezza a risvegliare in noi l’amore per la vita? Il mare diventa cattivo, le onde spazzano la zattera, buttandoci in mare, ma poi tutti, raccogliendo quel filo di forze che ancora ci rimane, ci spingiamo disperatamente di nuovo verso il relitto.
In questo alternarsi di momenti tragici mi addormento, mi assopisco, forse per le fatiche e sogno. Un’altra onda mi ributta in mare, svegliandomi. Risalgo e racconto. – all’unico compagno della zattera – che avevo trovato un amico in bicicletta che, pedalando disperatamente sul mare, mi invitava a mangiare un piatto di spaghetti ad una trattoria che si vedeva da lontano. Il mio collega ha fame come me e mi invita a riprendere le trattative con il mio amico. Non so e non ho mai capito se il suo era il ragionamento di una persona convinta. Forse sono già i segni di squilibrio mentale, forse sono i preludi della morte?
La nave si fa più vicina e si riallontana di nuovo. L’approssimarsi suggerisce di gettarci in acqua, ma il buon senso ce lo vieta, ed è bene, perché qualcuno che precedentemente l’aveva fatto non è arrivato a destinazione: stremato dalla fatica, è stato vinto dall’oceano.
Si pensa di fare una vela con le nostre camicie e di remare con le mani, ma non ne abbiamo più la forza. Ed il vento, poi, ci spingerà nella direzione giusta? Ormai si rinunzia a tutto.
La notte passa, più paurosa della precedente. Si ha il timore, infatti, di non essere visti dalla nave salvatrice. Perdendo questa opportunità, ogni speranza diventerebbe vana. In questi ossessionanti momenti si aggiunge alla depressione morale la stanchezza fisica. Si vivono ore tremende, momenti pericolosi per la nostra esistenza. Siamo qualcosa che un nulla può annientare per sempre.
L’alba del terzo giorno arriva e con essa si rinforza la speranza, perché il “Castello delle mille e una notte” si avvicina sempre più a noi. Eccolo visibile.
Adesso, a gran fatica per i nostri occhi, si distinguono perfino i colori della bandiera dipinti sul fianco: sono rosso e verde. Con un po’ di fantasia si confonde lo stemma centrale col bianco e si grida che è una nave italiana.
Di che nazionalità sia, non importa, l’importante è salvare la pelle. Ancora una volta si allontana ed io mi assopisco per la stanchezza. E’ circa mezzogiorno, il sole è tornato forte nel cielo e la stanchezza è più forte di noi.
Un suono di campanella mi sveglia. E’ la campanella di bordo, faccio per sedermi sulla zattera per vedere, ma due marinai mi fanno capriolare sulla scialuppa. Sono sfinito, ancora un minuto… e… Issata la scialuppa a bordo, sono sorretto da due marinai. Sono due cadetti della marina portoghese che parlano un italiano corretto. Sono un automa nelle loro mani. Vengo denudato degli ultimi stracci, come per cancellare in me gli ultimi ricordi di una grande tragedia e vengo portato alle docce. Il mio organismo non ha la forza di reggersi in piedi, dopo le 52 ore di naufragio, ed un marinaio, sorreggendomi, mi lava alla meglio per tirare via la patina d’olio che ricopre il mio corpo e nasconde qualche probabile ferita. Se anche non riesce a lavarmi bene, la frizione dell’acqua calda riattiva un po’ la circolazione del mio sangue, quasi paralizzato. Un senso di tepore mi fa riacquistare un po’ di forza. Condotto all’infermeria, sono esaminato minuziosamente. Non ho nulla di preoccupante. Il mio stato suggerisce però al medico di trattenermi in infermeria. I quattro letti sono occupati, mi si destina il posto vuoto a terra. Il
fatto di appoggiare sul solido e di essere avvolto e protetto da una coperta mi ridà la forza per riordinare le idee.
Ritorno alla vita
Chiedo prima di tutto un bagno in vasca, che mi viene concesso. Con tutte le mie forze muovo i primi passi. Trovo qualche conoscente, chiedo informazioni di amici. La risposta è avvilente. La tragedia ha risvegliato in ciascuno di noi quel senso egoistico che nella nostra vita normale cerchiamo di coprire. Ci si riavvicina, si fanno considerazioni,ci si ambienta di nuovo. Siamo finalmente salvi e questo è l’importante, liberi da ogni incubo di campi di concentramento. Una sola cosa ci preoccupa. Cosa avverrà di noi? E’ una preoccupazione passeggera, che finisce nel nulla. Ormai nudi, aspettiamo la nuova destinazione. E’ un ritorno alla vita che ci solleva lo spirito e ci riempie di gioia.
Si dimentica il passato. Qualche ricordo di tanto in tanto ci intristisce, ma il mondo che ci circonda ci rimette in allegria.
Vestiti da marinai, con coperte o con lenzuola sulle spalle, giriamo sulla tolda della nave da guerra portoghese “Alfonso de Albuquerque” come tanti fantasmi, fantasmi della paura, ma ci tocchiamo con soddisfazione perché siamo viventi.
Il mare ha lavato il passato e la vita si riapre ai nostri occhi. Qualcuno si interessa di classificarci, catalogarci, cosa che ci dà ancora l’impressione di essere in un campo di concentramento. Viene voglia di gridare “BBBASTA”… No, questa volta, è un connazionale che cerca di elencare gli scampati per comunicare poi notizie alle rispettive famiglie.
Ci danno da mangiare. E’ un piatto schiettamente nazionale portoghese, “baccalà albardado”, in italiano si chiamerebbe baccalà fritto. E’ meraviglioso ma non si riesce a spingerlo attraverso l’esofago, forse si sarà chiuso per sempre, non avendo lavorato per due giorni; o è stato ostruito dalle sostanze oleose ingerite? Ricorro ad uno stratagemma: ingerisco il boccone con l’aiuto del liquido di una tazzina, di cui non sento il sapore ma che più tardi mi dicono che era grappa. La digestione viene riattivata a poco a poco e con un po’ di sforzo tutto si normalizza. Ci si comincia a riabituare a tenere il nostro corpo verticalmente.
Bighellonando per la nave si trova qualche amico, si scambia qualche opinione con lui e si fanno delle considerazioni; talvolta sono amare, e si resta muti, o sono rosee e il nostro volto per qualche momento si illumina.
Mi imbatto in un mucchio di stracci e tra essi ritrovo i miei pantaloni, che avevo lasciati al momento del salvataggio. Mi ricordo che nella cintura avevo nascosto dei biglietti da cinquanta lire, sottratti alla solita perquisizione nemica, perquisizione fatta al solo scopo di soddisfare il desiderio soldatesco di trovare qualche cosa, qualche oggetto ricordo. Nascosti nella cintura sono lì. Li conto: uno… due… sei, ci sono tutti. Meno male, so che non mi servono a niente, ma saranno un ricordo da portare con me per tutta la vita. Qualcosa che un giorno mostrerò ai nipoti e mi servirà di pretesto per iniziare un racconto. Triste, interessante, che racconterò come un sogno vissuto, qualcosa di lontano, che si perde nei flutti di un oceano.
Da un primo conteggio risultiamo centodiciannove ed una cinquantina di inglesi, sudafricani e mariani della nave.
Circa mille i morti, di cui più di seicento italiani. La perdita è enorme, anche perché il carico era prezioso. In un colpo solo sono spariti circa 200 professionisti: direttori di banche, medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti e alti funzionari di governo. Accanto a loro sono andati via anche gli umili operai che hanno con il loro sudore impastato il pietrisco delle strade per permettere il passaggio dei rifornimenti per i lontani centri, e i marinai delle tante navi affondate a Massaua, che aiutarono a trasportare tali rifornimenti dall’Italia. Tutti avevano contribuito a fare un impero grande; tutto è scomparso in un dolo colpo.
Ogni tanto si torna alla realtà e si abbandonano tali pensieri. Questa volta è un insolito movimento. A bordo nessuno sa cosa succede. Quelli che si possono muovere corrono sul ponte e poi vengono a riferire. Una nave da guerra sudafricana è apparsa all’orizzonte a chiedere al comandante della “Alfonso de Albuquerque” di dirottare verso Durban, dove musica e festeggiamenti avrebbero accolto i naufraghi.
Il comandante risponde secco che è deciso di portarci nel Mozambico.
L’ordine, infatti, è di sbarcarci a Lourenco Marques. Questa decisione fa zittire il comandante sudafricano, che ripiega alla base. La nostra ammirazione per il nocchiero ingigantisce e se ne fa un eroe. Il comandante Brito viene portato da noi in palmo di mano.
Nel nostro bighellonare ci si imbatte in qualche inglese. Il contegno è corretto, non vi sono motivi per inscenare delle brighe dopo quello che si è passato. Il tenente che ci accompagnava è lì con noi, seduto ad un tavolo, vicino a lui ci sono la moglie dell’ufficiale italiano, sudafricana di nascita, e qualche naufrago italiano. La signora pare che sia lì per stabilire il contatto fra i due gruppi.
L’inglese si sforza di stringere amicizia con noi, offrendo sigarette. Nessuno di noi si preoccupa di quest’atto perché pensa ad altro.
La sera arriva e si va a dormire presto, anche perché il mare diventa cattivo. Verso le 10 vengo svegliato. Pare che un nostro connazionale sia morto. Viene gettato in mare. Colgo l’occasione per occupare il lettino vuoto.
La mattina ci si sveglia prestissimo. I marinai già da un pezzo sono svegli ed hanno rimesso tutto in ordine, ogni cosa a suo posto. Molti di loro sono guardiamarina, bravi cadetti che continueranno un giorno la tradizione dei loro antenati. Vorrei ritrovare quello che parlò italiano, per ringraziarlo della sua gentilezza, ma non mi riesce perché non ricordo il suo volto, quel volto che potrebbe essere quello che mi guarda. Non è lui, è uno simile. Mi offre una sigaretta, l’accetto. Quell’atto ancora una volta mi commuove ed il mio sguardo si spinge sulla costa, che già si profila all’orizzonte. Vedo case sotto palme altissime, ammiro il panorama e mi vien fatto di idealizzare il posto. Che bello.
Mi fisserò, se mi sarà possibile, fra quelle palme. Sono scosso intanto da qualcuno e rientro nella folla.
I preparativi dello sbarco sono quasi finiti. Il medico del porto è a bordo e ci esamina attentamente. Il porto è pieno di gente. Vi è anche qualche connazionale incuriosito. Probabilmente non sa che a bordo vi sono centodiciannove italiani, che parlano la sua lingua e che hanno bisogno di attenzione.
1 dicembre 1942
E’ per i portoghesi un giorno di Festa Nazionale, per noi, invece, è il primo giorno di vita. Ci sembra infatti di rinascere. Si sbarca. Chi a piedi, chi in lettiga, chi appoggiato a qualche amico più forte. I camions ci aspettano lì, in ordine, sono camions militari a cui siamo già abituati e non pensiamo che essi invece ci porteranno verso la libertà. I più sani sono indirizzati ad un quartiere di soldati, i meno all’ospedale civile. In un primo momento non si fa distinzione di nazionalità, ma all’arrivo siamo separati per questioni di prudenza. Molti si rifugiano nell’ospedale, ma, quando sanno che gli altri sono liberi, si precipitano fuori a raggiungere i loro compagni. Si fanno nuove conoscenze.
Nel pomeriggio arriva qualche italiano residente, che, venuto a conoscenza del fatto, si è precipitato a visitarci. Gli chiediamo qualcosa di cui abbiamo urgente bisogno; va e ritorna per accontentarci.
Il giorno dopo, essendo stato comunicato ufficialmente alle autorità italiane il nostro arrivo, il Console e i suoi impiegati vengono a farci visita. E lì anche il Console tedesco, nostro alleato.
L’entusiasmo è tanto forte che si canta “Giovinezza”. Gli inglesi brontolano. Vola qualche imprecazione, i rapporti diventano tesi. L’arrivo del Console inglese non porta altre novità, se non quella di allontanare i suoi, eliminando il pericolo di noie.
Passa qualche giorno e arrivano i primi doni. Una volta è il pigiama, che sostituisce il lenzuolo che serviva per coprirci nelle nostre brevi passeggiate all’aria libera; poi è il dentifricio con lo spazzolino, le pantofole, il rasoio per la barba, sigarette e quanto altro richiesto da noi. Il Console fa il possibile per accontentarci in tutto, chiedendo aiuto agli italiani residenti più benestanti.
Qualcuno, passeggiando, involontariamente si avvicina alla porta, la sentinella portoghese, a gesti, gli fa capire che può, se vuole, uscire. Solo in quell’istante capisce cosa vuol dire libertà. Deve rinunziare anche adesso, perché è in pigiama e pantofole. Al ritorno del Console si fa notare la cosa e ci viene fornita una sahariana, fatta espressamente per noi. Il contatto col mondo civile tarda qualche giorno, ma è sicuro. Abbiamo atteso tanto e ci assoggettiamo all’ultima attesa.
La divisa ci fa tutti uguali e ci affratella ancora di più. Si esce in gruppi. Gli italiani ci riconoscono subito e si stringono relazioni. I portoghesi anche, ma sono un po’ freddi con noi. Passa qualche giorno e scopriamo il perché. Gli alleati hanno sparso la voce che noi siamo ex prigionieri civili, sfollati dalle carceri eritree per far posto ad altri. I soldati portoghesi vengono a conoscenza
del fatto e si prodigano, avendoci conosciuti, a far si che questa macchia scompaia per sempre.
E’ la nostra salvezza e si familiarizza con tutti. Le donne, vedendoci fermi davanti ai carrettini della frutta che girano per la città, ci offrono di scegliere quello che vogliamo. Sanno infatti che le nostre possibilità non ci permettono tali lussi. Per noi è la vita. Si mangia a sazietà e si vive tra persone comprensibili. La vita ci appare meravigliosa perché ognuno di noi pensa al passato e si ritiene felicissimo del nuovo stato, anche se in tasca vi è solo qualche scudo, e non si pensa al domani. Tutto ci appare bello, anche le cose più insignificanti.
Qualche giorno dopo arriva una notizia: un naufrago su una zattera, esattamente dopo una settimana, è stato sbattuto sulla spiaggia di Durban.
Siamo così arrivati a 122. Per gli altri non c’è più speranza.
La immane tragedia volge alla fine, ma per noi resta un fatto. Tanti nostri connazionali sono morti, tanti ricordi sono sepolti nell’Oceano Indiano. Forse il tutto si poteva evitare. Molti, infatti, passati i giorni tempestosi, si domandano, raggiunta la calma: perché gli inglesi trasportavano dei civili evacuati dall’Eritrea, con una nave ausiliare armata e con soldati a bordo? Usando le convenzioni internazionali si sarebbe potuto evitare la tragedia? E perché non hanno provveduto, evitando così tutta la colpa al sottomarino tedesco, che francamente era ignaro di tutto?
La vita continua
Di giorno in giorno ci rendiamo conto del nostro nuovo stato. Si organizza una commissione per portare un regalo al comandante Brito. E’ un piatto d’argento con su una dedica. Il comandante riceve la commissione e accetta, commosso, il regalo. Il giorno dopo fa mostra nella sua saletta di ricevimento, accanto ad un altro offerto dagli inglesi. Le due nazioni, in terra portoghese, erano unite ancora una volta, come nella tragedia.
Il comandante racconta ed il suo racconto va di bocca in bocca. A noi interessa come una favola può interessare un ragazzino. La similitudine non è azzardata perché noi abbiamo cominciato una nuova vita, avendo seppellito il nostro passato in fondo all’oceano. Apprendiamo così che dobbiamo la nostra salvezza al sottomarino tedesco. Al momento dell’affondamento, infatti, la nave non fece in tempo a trasmettere la posizione giusta. Il sottomarino tedesco, invece, seppe dare tutte le informazioni, compresa quella che tra i naufraghi vi erano degli italiani. Berlino ricevette la notizia e si mise in comunicazione con Roma, che a sua volta comunicò l’accaduto a Lisbona. Da lì partì l’ordine per l’”Alfonso de Albuquerque”, che arrivò a mezzanotte del 28 novembre. Il comandante mandò in giro la ronda per raccogliere tutti i marinai e salpò con l’equipaggio incompleto. Seguendo un itinerario prestabilito e studiato in base alla posizione e al vento, stabilì su una carta di navigazione un rettangolo da perlustrare. Il rastrellamento cominciò all’arrivo sul posto e la nave, andando a zig-zag, raccolse i superstiti.
Egli è soddisfatto del lavoro ed è convinto di avere fatto il possibile per la raccolta dei naufraghi. Infatti, non poteva essere altrimenti. Tutto il rettangolo è stato perlustrato minuziosamente ed il pomeriggio del giorno seguente, finita la missione, diede ordine di rientrare a Lourenco Marques.
Gli ufficiali della Marina Mercantile Italiana di stanza a Massaua si congratulano con lui per il bel lavoro fatto e per l’attivo lavoro dei marinai portoghesi, che, prodigandosi fino all’inverosimile, hanno dato tutto se stessi per il buon esito dell’impresa.
Ci si sistema pian pianino. Gli inglesi alla spicciolata se ne partono per il Sud Africa. Noi, italiani, ci sistemiamo in case, in pensioni e viviamo da rifugiati, attendendo sempre, di giorno in giorno, qualche notizia che ci possa interessare. Intanto gli avvenimenti italiani precipitano e la situazione diventa critica.
Il Console non sa dove attaccarsi per rispondere alle nostre richieste. Abbiamo bisogno di tutto e di essere assistiti, perché, con tutta la nostra buona volontà, ci è vietato di lavorare. Qualcuno riesce ad entrare in qualche ditta, ma la ditta è minacciata di chiusura se non licenzia il volenteroso.
A braccia conserte, si assiste inoperosi agli avvenimenti, ma conserviamo la nostra calma e tutto ci sembra interessante e ci serve per mantenere in attività la nostra mente.
Arriva l’Armistizio a complicare ancora più la nostra vita. Litigate tra connazionali di idee differenti, espulsione del Console, dichiaratosi per la Repubblica. Passiamo tutti, seduta stante, sotto il controllo della polizia portoghese.
Intanto si apprende che alcuni corpi mutilati sono giunti sulla spiaggia orientale dell’Africa, nei pressi di Durban. Dicono che sono di italiani periti nel naufragio.
Ci si priva di quella sigaretta, che è la nostra compagna nell’ozio, si evita di comprare un paio di scarpe per risparmiare e si riesce a raccogliere circa diecimila scudi. Servono per un monumentino da costruire nel cimitero di Durban, dove sono sepolte circa 120 salme di italiani. Il monumento rappresenta una colonna spezzata, travolta dalle onde.
La polizia lavora per il nostro rimpatrio. Precedono i vecchi, gli ammalati, seguono gli indesiderabili, classificati tali dalla Polizia, infine partono i desiderosi di tornare a casa. Alcuni restano perché hanno trovato lavoro e sperano nell’avvenire. Ancora una volta si attaccano a questa terra d’Africa, da cui potevano essere scacciati per sempre. Sentinelle avanzate, guardano il mare infido, che, come un’ immenso sarcofago, raccoglie le spoglie di qualche amico caro che l’Africa aveva fatto conoscere.
Ogni tanto la mente cade lì. Si torna ai momenti tragici e tutto sembra oggi più bello. La vita sta continuando…
Vitale Moffa
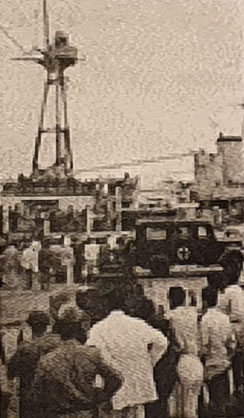
Arrivo dell'Afonso de Albuquerque alla banchina del porto di Lorenzo Marques il 1 dicembre 1942.
Lettere inviate a Maria Pia Pezzoli da compagni di sventura in ricordo del marito Giovanni Ellero perito nell’affondamento della Nova Scotia
RICORDO DI GIOVANNI ELLERO
Lorenzo Marques, 28 marzo 1943
Distinta Signora,
ho avuto tramite il nostro Consolato il messaggio che mi ha inviato a mezzo Croce Rossa Internazionale e la ringrazio tanto per gli auguri che mi fa. Mi sono subito recato al Consolato ed ho fatto rispondere a Croce Rossa di Lorenzo Marques – La prego scusarmi se non Le ho scritto subito, ci ho pensato molte volte, ma devo confessarle che mi è sempre mancato il coraggio doverle comunicare una notizia così triste – Le racconto così in breve come si sono svolte le cose di quel pauroso naufragio – Pochi minuti prima del disastro stavo in compagna di Suo marito, e ci stavo spesso durante il giorno, perché era per me un piacere conversare con Lui avendo subito dai primi giorni apprezzato le Sue alte qualità di mente e di cuore – Al momento del disastro l’ho visto e l’ho anche chiamato, mi ha risposto “coraggio” ma poi ad un altro sbandamento della nave io mi sono lanciato in acqua – e da quel momento non l’ho più visto perché un po’ a nuoto, per allontanarmi dalla nave che stava per colare a picco, un po’ trasportato dalla corrente, mi sono trovato al largo solo, lontano dal gruppo dove si trovavano molti naufraghi aggrappati ad alcune zattere ed a molti altri zatterini di salvataggio – Io, dopo otto ore circa ho trovato un tavolone e sopra questo ho passato la notte e l’altro giorno ancora poi sono stato tratto in salvo dalla nave portoghese accorsa in nostro aiuto.
Dopo le prime ore mi sono occupato e preoccupato della sorte di Suo marito ed ho saputo da un suo amico, Carlo Dominione, corrispondente dell’ex Corriere Eritreo, che il Dottore, alla sera alle 20 (il naufragio è avvenuto alle ore 9,24 del mattino) stava con altri aggrappato ad uno zatterino, era in Lui una calma assoluta, incitava i compagni a resistere e quel che più mi ha colpito il cuore, il povero Dottore pregava, pregava trasmettendo così questo sentimento anche agli altri – poi è sopraggiunta la notte, il mare si è agitato, forse trasportati da correnti diverse ci siamo allargati e da quel momento per molti e molti è avvenuto l’irreparabile.
Mentre le scrivo ho il cuore gonfio di dolore e la prego volermi perdonare la brutalità con la quale le comunico queste cose, sento però che è mio doloroso dovere farlo -
Devotissimo
Carlo Formai
Lourenco Marques, 11 giugno 1943
Gentile Signora Ellero,
ho saputo dal signor Formai del vostro desiderio di avere qualche particolare circa la fine del vostro Sposo e, malgrado non abbia molto da aggiungere a quanto in proposito ne scrissi già a mia moglie, tuttavia mi faccio dovere ripetervi e completarvi quel poco che so.
Nei brevi mesi di vita trascorsi assieme al Campo di Decamerè, fra me e il buon Dott. Ellero si erano stabiliti rapporti di ottimo cameratismo e di calda simpatia: fu quindi con vera gioia che Lo ritrovai a bordo nella mia stessa stiva. Passammo lunghe ore assieme in un gruppo formato quasi sempre da noi due, Caldiron, Bignami, Tinti, Ottavi e Silvestro. Io non so e non posso tesservi l’elogio della Sua figura, né oso dirvi quale e quanto fosse il contributo morale ch’Egli apportava alla nostra compagnia: trovo ogni frase insufficiente ed ogni aggettivo inadeguato. Voi, che ben Lo conosceste, potete immaginarvelo. Alla vigilia della tragedia, onde disporci in ordine alfabetico per lo sbarco, ci divisero: la mattina di poi avvenne il siluramento e solo nel tardo pomeriggio il vento e le correnti ci riunirono in un gruppo assai numeroso. Neri di nafta, già tutti provati dalla fatica, in lotta continua col mare agitato che ci voleva strappare ai piccoli relitti ai quali eravamo aggrappati, stemmo alcun tempo nel gruppo senza riconoscerci. Poi la Sua voce si elevò, serena, sicura e dolce per invitare tutti a una preghiera: ci riconoscemmo e fu un grido di gioia, seguito da un’incrociarsi affannoso di domande sulla sorte di tanti altri amici, alcuni dei quali erano appunto nel gruppo con noi. Lui era solo: due assi sotto le ascelle, un salvagente sotto la nuca, tentava di star coricato sul dorso il più a lungo possibile, tentando di tener appoggiati i piedi sul prolungamento dei due assi.
Rincuorava tutti, aveva parole di Fede sublime, e pregava, e pregava, pregava: “…Gesù, Giuseppe, Maria…” Invitava tutti a far sforzi per rimanere uniti, a non lasciarsi portare né dal vento né dalle correnti…ma le forze di molti non rispondevano più, e di ora in ora il numero dei morti cresceva. Fino a mezzanotte resistemmo bene: dopo, ebbimo tutti periodi di assopimento, ed io non conservo lucido il ricordo del tempo trascorso dalla mezzanotte a giorno.
All’alba rinvenni del tutto e mi guardai intorno: ero solo! Al sorgere del sole si unì a me un altro “isolato” insieme al quale tribolai fino al tramonto, quando fummo raccolti, ai limiti ormai di ogni possibile resistenza. A bordo della nave salvatrice, appena rimessomi un pochino, andai subito alla ricerca di Lui: fra i salvati non c’era e nessuno aveva Sue notizie. La nave incrociò ancora nelle acque della tragedia fino all’indomani sera, raccolse qualche rarissimo disperso ma di Lui, più nulla! Purtroppo non si possono neanche alimentare illusioni: la nostra posizione in mare, lontani dalla costa, i mezzi di ausilio consistenti in minuscole zatterine e relitti o rottami di legno, la mancanza d’acqua e di viveri (con che spasimo si apriva la bocca e si tirava fuori la lingua, la notte, nel tentativo di raccogliere qualche goccia di quella pioggia che, quasi incessantemente, cadde per lunghe ore dal cielo come un supplizio di Tantalo!), le energie di ognuno ormai privatissime, non permettono assolutamente di poter pensare al miracolo. Si può affermare che, dei morti in mare, la quasi totalità spirò nell’incoscienza. Fin che le forze assistevano, si lottava, ci si teneva aggrappati, ci si aiutava, ci si incoraggiava; e quando le forze cedevano subentrava l’incoscienza, l’insensibilità, l’inazione: la testa reclinava, un’ondata strappava dalla zattera o dal rottame, ed era la fine. Questo, Signora, ritengo sia quel tutto che vi possa interessare e di mia conoscenza, vi resti, col ricordo di Lui, l’orgoglio e la certezza di una condotta superba e degna solo di Se stesso fino alla fine, fino al limite delle possibilità umane.
Ho partecipato e partecipo al vostro dolore e conserverò il ricordo della sua amicizia come uno dei doni più belli che mi abbia prodigata la vita. Accettate i sensi del mio profondo rispetto e della mia leale devozione.
Angelo Zolisi
Dal sito www. bbc.co.uk/ww2 peopleswar/stories/
LA TESTIMONIANZA DI UN SUPERSTITE INGLESE
I served in the Royal Navy from July 1940 to February 1946 as the convoy signalman (serving in the merchant ship made commodore of the convoy).
In November 1942 in SS Nova Scotia, we were returning to Durban, South Africa from Port Tewfik, Egypt (via the Red Sea) alone. In Massawa Eritrea we collected about 800 civilians and 1200 South African soldiers (as guards). The voyage was uneventful until we were within about 24 hours of Durban, South East of Lourenco Marques on November 28th. It was 9am and I was off watch and just starting to clean up our bit of the mess deck “crash!” and a second later “crash!” two tinfish. From out of the alleyway and up the nearest ladder (water already pouring down) up to the bridge to do anything that might need doing (nothing did) and to the main deck to get the life rafts overboard. After a few minutes I decided it was time to abandon ship. Instead of a drop of 10 to 15 feet I stepped into the ocean and struck out away from the ship. She went down after I had swum about 10-15 yards and I was sucked under. I came up through a thick oil slick and saw a large life raft about 50 yards away.
Though the sea was unbroken there was a heavy swell and so I could only see the raft every now and then. I must have stopped thinking as reaching the raft was not happening. Then came night, twelve hours as I was in the sub-tropics.
Time must have passed but I have no real memories as to what happened.
Then daylight and I seemed to be no nearer or further away from the raft. My swimming strokes were no more than pawing at the sea. No thoughts of anything, complete exhaustion, but a very powerful thought. I was about a yard above the sea looking down at the hulk which was me, saying “let go you silly
I must have almost reached the raft without knowing and a sailor saw me and pulled me on board. I didn’t know. Sometime later I realised that I was no longer struggling and came back to life.
Two days later we were picked up by a Portuguese warship and taken into Lourenco Marques, then by train (3 nights and 2 days) to Durban to carry on with a more uneventful life at sea.
As told to the staff of Chesterfield Library
Traduzione
Ho servito nella Royal Navy dal luglio del 1940 al febbraio 1946 come “signalman” di convoglio.
Nel mese di novembre del 1942 ero a bordo della SS Nuova Scozia e stavamo ritornando a Durban, Sudafrica, da Port Tewfik in Egitto (via mar rosso).
In Massaua, Eritrea ,abbiamo raccolto circa 800 civili e 1200 soldati sudafricani (come guardie a protezione della nave). Il viaggio era stato tranquillo fino a che non eravamo a circa 24 ore da Durban, sud-est di Lourenco Marques, il 28 novembre.
Erano le 9 a.m. ed avevo appena cominciato a pulire la piattaforma quando sentii un primo “crash!”, seguito subito da un secondo “crash!”.
Allora sono corso attraverso il corridoio fino alla scaletta più vicina (con l’acqua che già si rovesciava giù nelle stive) fino al ponte per rendermi utile (purtroppo non c’era molto da fare) per poi andare alla piattaforma principale per calare le scialuppe di salvataggio fuori bordo.
Dopo alcuni minuti fu deciso che era necessario abbandonare la nave. Decisi allora di gettarmi direttamente nell’oceano. Ho nuotato per circa 10-15 yarde per poi essere risucchiato verso il fondo. Sono riemerso, però, aiutato da una spessa chiazza di nafta ed ho visto una grande zattera di salvataggio a circa 50 yarde da me.
Poichè il mare era grosso riuscivo a vedere la zattera soltanto di tanto in tanto. Non riuscivo a raggiungere la zattera e pensavo di non farcela. Dodici ore dopo è calata la notte tropicale. Il tempo passava ma non ho memoria di quanto è accaduto in quel frattempo. Tornata che fu la luce del giorno mi è sembrato di essere sempre alla stessa distanza dalla zattera. Le mie bracciate erano ormai non più che delle manate maldestre al mare. Nessun pensiero mi passava più per la mente, ero all’esaurimento completo. Senza rendermi conto però ad un certo momento mi sono avvicinato alla zattera e un marinaio che mi ha visto mi ha tirato a bordo. Non ricordo nulla di quei momenti. Solo successivamente mi sono reso conto che non stavo più lottando ed allora sono ritornato alla vita cosciente di essere salvo. Non più di due giorni dopo siamo stati recuperati da una nave da guerra portoghese e siamo stati trasferiti in Lourenco Marques, per poi continuare il viaggio in treno (3 notti e 2 giorni) verso Durban.
Testimonianza resa al personale della biblioteca di Chesterfield
Dal sito Internet:
www.tekkieraces.co.za/springbok/2008/inhoud/pieter_snyman_e.pdf e tradotto dall’inglese.
“ALLA DERIVA IN MEZZO AL MARE”
“Driftwood from the sea”
A few weeks later Pieter was informed that he had obtained a pass to go home.
At Suez he boarded the Nova Scotia, a ship headed home. At Massawa, American troops disembarked and Italian prisoners of war were taken aboard.
Having little to do except tolerate the sweltering heat of the desert coast, Pieter one day decided to entertain his friends by diving from the second deck of their ship into the water below. It was when he was repeating the feat and reaching for the dangling rope at the side of the ship that he caught sight of a large shark ready to strike out at him.
He grasped at the rope and tore himself away from its jaws. He decided not to dive again that day. But his skirmishes with sharks were far from over.
The Nova Scotia ploughed south for eighteen days. At night the Italian prisoners of war sang melancholy songs, which made Pieter long for home. On the rocking ship he would often think of his friends. Of the three companions from South Africa he was the only one to return home. 28 November 1942 The eighteenth day on a moody sea was a boisterous one. The Nova Scotia was on a zig zag course to frustrate a possible German submarine attack. The seasurface was foamy and uneven. It was barely possible to sight a periscope. But the German U-177 had been long in preparing for this encounter. At 9 o’ clock it was waiting under the surface, barely 300 meters away. Its commander, Kapitänleutnant Robert Gysae, was watching the approaching ship. Durban was about 250 km away, and the Portuguese harbour city of Lourenço Marques (Mozambique) only 80 km. The Nova Scotia was heading for the jaws of death.
One moment all was quiet. And then a torpedo tore through the ship with shattering shock. This was followed by another one, and a third. Pieter had just emerged from the hold of the vessel. The sudden explosions swung him off his feet and right across thedeck, where he barely succeeded in grabbing the railings on the other side. The large hulk rolled once and then heaved to the port side. Immediate chaos reigned. Inside the ship secondary explosions followed, and voices yelled wildly. By now the deck was on fire.
Hundred of Italians were pushing against the hand-rails, afraid to jump, but at the same time blocking the way. Agitated victims ran across the deck, their scalded bodies in shock. The engines had ceased and tons of water were streaming into the vessel Most of the life boats were in tatters. Others fell into the sea and disappeared. Pieter summed up the situation: his only hope was a safety-jacket before trying to escape.
He clambered up the side of the ship and found one. Wearing only a pair of khaki shorts and the jacket he dived from the upper deck into the restless Indian Ocean. He swam under water until his strength almost failed, and surfaced in dark, sticky oil. He found a raft constructed of wood and oil drums.
By now the ship was going under fast. Only a part of the deck, teeming with people, was visible. No-one clutching to the sinking vessel could be saved any more. In the hold of the ship people were fighting the water, attempting to find a way out. Those on deck stood frozen. They had obviously accepted the inevitable. “And then, as if it had been waiting for a sign, the sea uttered a hideous soughing sound, and when the gigantic hole in the ocean closed, large waves enveloped the struggling swimmers. Then silence. Pieter: “Before me was a cruel scene of human anguish. We were surrounded by the mighty ocean, its gluttonous billows battering defenceless human specks. Around us were scattered pieces of wood, doors and rafts. Fearful faces were bobbing in the waves, watching for something to hold on to. One by one they disappeared from sight.
Pieter found a long rope on the raft and hurled its end towards a group of struggling swimmers. Some were already too weak to make use of the opportunity. Once more Pieter dived into the water and started bringing men to the raft. By the time there were two South Africans and fifteen Italians on board, he was exhausted. He nevertheless grabbed an oar and without further ado declared himself captain of the vessel!
The raft was unexpectedly pushed off the hull of the U-177 which was surfacing, endeavouring to ascertain which ship had been torpedoed. There was no attack, but two Italians (German allies) were taken aboard before the submarine hastily disappeared under the waves.
Loneliness once more. Men were still drowning at regular intervals. The raft had too many men aboard and everyone was partially submerged. Any one new arrival would lead to everybody’s death. Some men were clutching to the sides of the raft. Others gave up quickly, throwing up their hands as if in final prayer before they sank.
Death in another form was also looming ominously. A lonely swimmer suddenly yelled wildly as he was pulled down. Bloody bubbles immediately surfaced.
Sharks! The Two South Africans had been fearing this.
“In the history of the Indian Ocean there has never again been a shark attack like this one. It was as if a shoal of man-eaters had appeared from nowhere.
The appearance of the sea was gradually getting more violent, and mammoth waves were booming over the seventeen men. Night came without sleep.
Cutting winds lashed out and rollers crashed unceasingly. Every now and then the wretched men changed positions. Those on the outside moved to the centre, and then back. Ever so often a fivemetre shark threateningly swam near the raft. Day came, and with it a sense of hope. But the surrounding ocean had nothing encouraging to offer. Most of the wreckage was not visible any more.
Some of the nearby rafts had no men on them. And the sharks were still circling.
On the second day a rash decision was made. Cork jackets were removed and torn apart to be fashioned into a rough sail. At least the wind would steer them in some direction. In the course of the second night weary eyes searched the sea for some sign of light. One was indeed spotted, about fifteen to twenty kilometres away. When it disappeared it seemed as if all hope followed suit.
Fighting a visible enemy is difficult enough, but this was an anxious gamble with some invisible power. Emotions ran high. Seventeen desperate men without water or food.
Some men started hallucinating on account of unbearable hardship. Some babbled incoherently, others started cursing. Yet others lapsed into a coma. No wonder – their tongues were swollen, their lips cracked, their eyes pools of blood due to the oil and weather conditions.
On day three most of them had surrendered to the reality of death. Pieter was holding out and asked a redhead Italian who was still in his right mind to grab his legs and lift him up. He just wanted to take a last look across the waves.
There might yet be some hope. After several trials, the two eventually succeeded, and Pieter had a glimpse across the ocean. He stared in unbelief, and stared yet again. Is it at all possible? A cross? A moving cross? For some reason the words of a song learnt in his youth nestled in his mind: On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suffering and shame; And I love that old cross, where the dearest and best For a world of lost sinners were slain.
The cross became clearer. The radio masts of a ship! Then, like an angel of mercy, a large vessel rocked to a standstill and ropes were thrown at them.
When the crew realised that they were surrounded by sharks, a life-boat was lowered. On board they sank to the floor and was given hot coffee to drink and blankets to wrap themselves in.
But the world had suddenly become a revolving disk. Sleep that everybody had been dreaming of, was gone. Soon afterwards death started taking its toll.
Captain Jose Augusto Guereiro de Brito gave quick orders, and the Alfonso de Albuquerque started on its way to Lourenço Marques.
Of the 1266 passengers on the Nova Scotia only 192 would arrive alive in LM.
One hundred and twenty dead bodies were washed out on beaches in Durban, and these were removed early in the morning to prevent unnecessary panic. The South Africans received a great welcome in LM, but they quickly realised that they were sure to be interned. During a party arranged for them by the South African Consul, they were secretly informed that they would have to look after themselves from that moment on.
Pieter and a friend lost no time, found two bicycles somewhere, which they rode barefoot because their feet were still badly swollen. At the railway station they were scared away by officials and eventually slept fitfully in a hut about 15 km outside LM. They started walking at daybreak, their destination the border sixty km away.
They bluffed their way through a few guarded bridges by mumbling a few words in Portuguese. They walked weary kilometres before they stopped a taxi a short distance from the border. Only then did they realize that it was a vehicle hired by the South African government to transport injured soldiers from a hospital in LM.
Swaziland. Nelspruit. Pretoria. Here the necessary formalities were taken care of. And it was time to go home! In Johannesburg a highly-strung Snyman-family were waiting in keen expectation. They had been informed that Pieter was
missing, and were now fearing the worst.
And then, during the day, he reached the street where he lived, and caught sight of the old house. He just opened the door and walked in…

Questo è il racconto di Pieter Johannes Jacobus (Pieter) Snyman, un altro dei pochi sopravissuti al naufragio della Nova Scotia. Egli nacque in Sudafrica il 6 aprile 1919. Trasferitosi con la famiglia a Johannesburg a causa della depressione economica, allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruolò nell’esercito con l’entusiasmo giovanile che lo caratterizzava. Dopo alterne vicende di guerra giunse finalmente il momento di tornare a casa…
…alcune settimane più tardi, Pieter fu informato di aver ottenuto un passaggio per andare a casa. A Suez si imbarcò sulla Nova Scotia, una nave diretta verso la sua patria. A Massawa, dalla nave, sbarcarono delle truppe americane facendo posto a prigionieri di guerra italiani. Non avendo altro da fare che tollerare il caldo soffocante, un giorno, Pieter, decise, per divertire i suoi amici, di tuffarsi in mare dalla seconda piattaforma della nave. Fu quando stava per accingersi a ripetere la bravura e stava per raggiungere la corda che ciondolava sul fianco della nave per la risalita che s’accorse del grande squalo pronto ad assalirlo. Subito afferrò la corda sfuggendo per un niente alle terribili mascelle.
Quel giorno decise di non tuffarsi più. Ma le sue schermaglie con gli squali non sarebbero finite quel giorno. La Nova Scotia solcò il mare, verso sud, per diciotto giorni. Di notte i prigionieri italiani cantavano delle canzoni così piene di malinconia che infondevano a Pieter la voglia struggente di essere a casa. Il dondolare della nave lo faceva spesso pensare ai suoi amici. Dei tre compagni di viaggio provenienti dal Sud Africa era l’unico che stava ritornando a casa. Il 28 novembre 1942 era il diciottesimo giorno di viaggio su un mare capriccioso e turbolento. La Nova Scotia stava navigando a zig-zag per cercare di sfuggire ad un possibile attacco da parte di qualche sommergibile tedesco che si sapeva essere in quelle acque. La superficie dell’oceano era caratterizzata dalla spuma delle onde provocate dal mare mosso. Era difficile poter individuare la presenza di un periscopio. Ma l’U-177 si stava preparando da molto tempo a questo incontro. Alle 9 a.m. in punto, era lì ad aspettare, a solo 300 metri di distanza, appena sotto la superficie. Il suo comandante, capitano di corvetta, Robert Gysae, stava guardando la nave avvicinarsi. Durban era a circa 250 chilometri ed il porto più vicino era la città portoghese di Lourenço Marques, in Mozambico, a soli 80 chilometri. La Nova Scotia stava andando verso la morte.
Nulla faceva presagire la tragedia. Tutto era all’insegna della tranquillità.
All’improvviso però questa fu squassata dallo scoppio della prima torpedine, seguita immediatamente dalla deflagrazione della seconda e della terza torpedine. Pieter, in quel momento, era appena salito in coperta proveniente dalla stiva. Le improvvise esplosioni lo scaraventarono violentemente da un lato all’altro del ponte, riuscendo alla fine ad afferrarsi ad un parapetto in ferro della nave. La carcassa della nave dopo aver sbandato una prima volta cominciò a sollevarsi a babordo. Fu il caos immediato. Dall’interno della nave, immediatamente dopo le esplosioni, provenivano urla di disperazione e di dolore. Ormai anche il ponte era preda delle fiamme. Cento italiani si ammassavano contro i corrimani, impauriti e timorosi di saltare in mare impedendo così agli altri di tentare la fuga. Le vittime bruciate dal fuoco correvano impazzite attraverso il ponte. I motori della nave avevano cessato di funzionare e tonnellate di acqua stavano affluendo nelle stive mentre la maggior parte delle scialuppe di salvataggio erano andate distrutte. Molti che erano caduti in mare subito scomparirono. Pieter valutava la situazione: la sua sola speranza era di riuscire a trovare un giubbetto di salvataggio prima di tentare la fuga in mare. Percorrendo un fianco della nave ne trovò uno. Vestito soltanto di un pantaloncino kaki e del giubbetto si tuffò dalla piattaforma superiore nell’agitato Oceano Indiano. Nuotò sott’acqua finchè glielo consentì la sua resistenza emergendo poi in un mare ricoperto da un olio scuro ed appiccicoso dovuto alla fuoriuscita della nafta dai serbatoi della nave. Trovò una zattera costruita con i fusti dell’olio e travi di legno. Ormai la nave stava affondando velocemente. Era visibile soltanto una parte del ponte, ricolma di gente.
Nessuna di quelle persone che stavano colando a picco con la nave si sarebbe potuta salvare. Nella stiva della nave altra gente stava lottando con l’acqua per trovare una via d’uscita. Quelli presenti sul ponte, ormai in posizione verticale, erano gelati dal terrore. Avevano, ovviamente, accettato l’inevitabile… “ed allora, come se stesse attendendo il segnale, il mare emise un suono spaventoso e quando il gorgo gigantesco si richiuse grandi onde avvolsero i naufraghi che lottavano fra i flutti”. Poi il silenzio. Pieter: “ Davanti a me una scena crudele di umana angoscia. Circondati da un oceano vigoroso, con le onde che colpivano le figure umane indifese. Intorno a loro i relitti, pezzi di legno, pezzi di portelli, resti di zattere. Cercavano tra i fronti d’onda spaventosi qualcosa a cui aggrapparsi. Uno per uno scomparvero alla vista”. Pieter trovando sulla sua zattera una lunga corda ne lanciò una sua estremità verso un gruppo di naufraghi che lottavano tra le onde. Alcuni erano già troppo sfiniti per cogliere l’occasione. Una volta di più Pieter si tuffò nell’acqua per portare quegli uomini sulla zattera. Alla fine riuscirono a salire a bordo due sudafricani e quindici italiani, dopodiché lui si autonominò, afferrando un remo e senza che nessuno si opponesse, capitano del vascello! Inaspettatamente la zattera fu urtata dallo scafo del U-177 che stava emergendo per accertarsi del risultato del siluramento. Non ci fu un atteggiamento ostile da parte dell’unità germanica, anzi, prima che il sommergibile sparisse nuovamente sotto le onde, furono presi a bordo due italiani (alleati dei tedeschi). Ancora una volta si ripresentò una situazione di solitudine. Ad intervalli più o meno lunghi qualcuno di quelli aggrappati alle zattere annegava. La zattera aveva troppi uomini a bordo ed era per questo parzialmente sommersa. Se qualche altro naufrago fosse arrivato poteva significare la morte di tutti. Alcuni erano aggrappati ai bordi. Altri si arresero rapidamente ponendo le mani unite in un gesto di preghiera prima di affondare. La morte, però, stava apparendo minacciosa in lontananza sotto un’altra forma. Un naufrago improvvisamente si mise ad urlare sfrenatamente e subito comparvero delle bolle di sangue in superficie. Squali! I due sudafricani della zattera stavano temendo questo. “Nella storia dell’Oceano Indiano mai vi fu un attacco di squali bianchi come questo”. E’ come se un branco di mangiauomini fosse comparso dal nulla. Il mare stava assumendo gradualmente un aspetto sempre più violento e flutti giganteschi rombavano sopra i diciassette poveri naufraghi. Passarono la notte senza dormire. Il vento tagliente continuava a frustare i sopravissuti provocando l’ incessante rollio della imbarcazione di fortuna. Di tanto in tanto gli sventurati cambiavano di posizione.
Quelli che si trovavano sui bordi andavano verso il centro e viceversa. Molto spesso uno squalo si avvicinava minaccioso alla zattera. Arrivò il giorno e con esso un senso di speranza. Ma l’oceano circostante non aveva davvero niente di incoraggiante. La maggior parte dei naufraghi non era ormai più visibile.
Alcune delle zattere vicine non avevano più nessuno aggrappato ad esse. E gli squali stavano ancora lì a circondarli. Il secondo giorno fu presa una decisione temeraria. Furono rimossi i rivestimenti in sughero dei giubbetti per formare una specie di vela rudimentale. Così almeno il vento li avrebbe diretti in una precisa direzione. Nel corso della seconda notte gli occhi esausti dalla stanchezza cercavano comunque un segnale luminoso qualsiasi. Un segnale effettivamente fu avvistato ed era ad una distanza di circa quindici-venti chilometri. Quando sparì fu come se fosse stata loro tolta ogni speranza di dosso. Il combattimento contro un nemico visibile è abbastanza difficile ma quello contro un nemico invisibile assume un aspetto oltremodo ansioso. Le emozioni dominavano gli uomini. Erano diciassette uomini senz’acqua e cibo. A causa delle difficili
condizioni alcuni cominciavano ad avere le allucinazioni, altri balbettavano qualcosa senza alcuna coerenza ed altri si abbandonavano alle imprecazioni.
Altri ancora cadevano in uno stato di coma. Non c’era da meravigliarsi. Le loro lingue erano gonfie, le labbra screpolate, i loro occhi arrossati dalle condizioni atmosferiche e dal petrolio. Al terzo giorno la maggior parte di loro avevano ceduto alla morte. Pieter stava resistendo ed a un certo momento chiese ad
uno degli italiani che ancora era in grado di ragionare di aiutarlo a mettersi in piedi sulla zattera. Voleva dare un ultimo sguardo attraverso le onde. Poteva ancora esserci un po’ di speranza. Dopo parecchi tentativi i due finalmente vi riuscirono e Pieter potè dare un’occhiata attraverso l’oceano.
Fissò l’orizzonte incredulo più di una volta. E’ mai possibile? Una croce? Una croce che si muove? Chissà per quale motivo gli vennero in mente, in quel momento, le parole di una canzone che aveva imparato in gioventù: Su una collina lontana era dritta in piedi una vecchia croce.
L’emblema della sofferenza e della vergogna.
Ed io amo quella vecchia croce, per la quale i più cari ed i migliori del mondo sono stati uccisi da dannati peccatori.
La croce diventò più visibile. Erano gli alberi radiofonici di una nave! Poi, come un angelo misericordioso, la grande nave, beccheggiando, si fermò gettando le corde ai naufraghi. Quando la squadra di salvataggio si rese conto che erano circondati dagli squali una lancia di salvataggio fu calata in mare. Una volta a bordo, ai superstiti fu offerto del caffè caldo e delle coperte con le quali coprire i propri corpi nudi. Il sogno di quei poveretti si era avverato. Il capitano Augusto Guereiro de Brito con rapidi ordini comandò alla nave, l’Afonso de Albuquerque, di riprendere la rotta verso Lourenço Marques. Dei 1266 passeggeri presenti alla partenza sulla Nova Scotia, soltanto 192 sarebbero arrivati vivi in Mozambico. Centoventi cadaveri sarebbero stati in seguito ritrovati, gettati dai marosi, sulle spiagge di Durban e in fretta e furia recuperati affinchè non si divulgasse la notizia della presenza nel mare sudafricano di sommergibili nemici al fine di non creare panico fra la popolazione. I sudafricani sbarcati a Lourenço Marques ricevettero un grande benvenuto ma allo stesso tempo sembrò ci fosse la possibilità che potessero essere internati in qualche campo.
Il consolato sudafricano per evitare questo li informò segretamente che se volevano tornare a casa dovevano arrangiarsi in qualche modo. Pieter ed un suo amico non persero tempo. Trovate due biciclette si misero immediatamente in sella pedalando a piedi nudi in quanto i piedi erano ancora gonfi per la lunga permanenza in acqua da non riuscire a calzare le scarpe. Alla stazione ferroviaria, spaventati per la presenza di funzionari locali, preferirono non prendere altri mezzi. Continuarono perciò il loro cammino, dormendo dove si poteva e superando i posti di guardia borbottando qualcosa in un cattivo portoghese. Il confine distava non meno di 80 chilometri. Camminarono fino allo sfinimento. A pochi chilometri dal confine col Sudafrica finalmente incontrarono un veicolo e lo fermarono per chiedere un passaggio. Fortuna volle che fosse un mezzo noleggiato dal governo sudafricano per trasportare i soldati feriti da un ospedale di Lourenço Marques verso la loro patria. Dopo le necessarie formalità furono fatti salire a bordo e si avviarono finalmente verso casa. A Johannesburg, i famigliari di Pieter erano in attesa spasmodica di avere sue notizie. Erano stati, infatti, informati che Pieter non era più rintracciabile per cui temevano il peggio. Ma intanto Pieter stava già percorrendo la strada in cui era
vissuto vedendo in lontananza la sua casa…
Sempre dal medesimo libro di Mascellari,
ancora altri racconti.
Il caporale Geroge Kennaugh, 36 anni all’epoca, imbarcato sulla nave a Tewfik stava andando in licenza a Johannesburg, meritatamente, dopo essere rimasto ustionato saltando in aria su una mina nei pressi di El Alamein. Anche lui aveva il compito di alternarsi nei turni di guardia ai prigionieri. Ecco il suo racconto.
Avevo finito il mio turno di guardia e dopo un bagno in piscina, stavo sonnecchiando pigramente sul bordo in costume da bagno. Faceva molto caldo ed il cielo era sereno.
Venni svegliato bruscamente dalle esplosioni. Il mio primo pensiero fu di andare a prendere, sottocoperta nel mio alloggio, i soldi che avevo vinto a poker giorni prima, ma mi resi conto che non avrei fatto in tempo. I siluri avevano colpito la nave nel centro, sul lato sinistro all’altezza della sala macchine e i serbatoi di carburante si erano incendiati. Le fiamme si erano propagate velocemente anche sul ponte di coperta, che era diventato un manicomio, con centinaia di persone urlanti che si ammassavano ai parapetti.
Tre lance di salvataggio sul lato sinistro erano state spazzate via dall’esplosione. Vidi dei membri dell’equipaggio intenti a calare in mare le tre lance di salvataggio del lato destro. Ci riuscirono con due di esse, ma con la terza le cose andarono male in quanto si ruppe un cavo e tutti gli occupanti finirono in acqua, e la lancia dopo aver ondeggiato per un po’ di tempo cadde in mare ed affondò.
Ero attaccato al parapetto mentre la nave si inclinava paurosamente. Dopo pochi minuti dall’esplosione, circa sette, la nave cominciò ad affondare. Mi gettai in acqua e cercai di allontanarmi per non essere risucchiato. Mi accorsi di essere bagnato di nafta e dovetti fare molti sforzi per cercare di non farmela arrivare nei polmoni. C’era nelle vicinanze un remo della lancia di salvataggio che era affondata, mi ci aggrappai e poco dopo arrivò un sudafricano che mi disse di essere ferito all’altezza dello stomaco.
A circa 400 yarde da me vidi emergere il sommergibile in mezzo a numerosi naufraghi galleggianti. Alcuni membri dell’equipaggio da ponte fotografavano la scena, ma ne vidi anche altri che si accingevano a scoprire le mitragliatrici con il palese intento di usarle contro di noi. Improvvisamente ad un cenno del comandante, anche lui sul ponte, rimisero tutto a posto. Ad un certo punto io e il mio compagno, ci accorgemmo con orrore di essere circondati dai pescicani. Cercammo di allontanarli. “Non posso continuare così, ora mi lascio andare, non ce la faccio più” diceva il mio compagno mentre io cercavo di esortarlo a resistere e a combattere. Mi resi conto però che era determinato a lasciarsi andare ed allora gli chiesi di lasciarmi il suo giubbotto di salvataggio. Mentre stava slacciarlo lo sentii urlare e vidi che l’acqua intorno a lui si tingeva di rosso: un pescecane gli aveva staccato di netto un piede, poi non lo vidi più.
Mi raggiunse poco dopo un sudafricano aggrappato ad un enorme bidone ed insieme ci avvicinammo ad una grossa zattera sulla quale c’erano degli italiani. Cercammo di salire a bordo ma fummo rigettati in acqua. Il sudafricano mi suggerì allora di valermi della mia autorità di guardia e di ordinare a quei prigionieri di farci salire sulla zattera. Gli dissi che in quella circostanza non mi avrebbero sicuramente obbedito. Allora egli passò all’azione. Era molto robusto ed usando una torcia, che galleggiava nelle vicinanze, come una clava, gettò in acqua degli italiani e prendemmo il loro posto sulla zattera. Subito dopo però fece risalire quelli che aveva gettato in mare. In questa zattera successivamente presero posto 22 sudafricani ed alcuni inglesi membri dell’equipaggio.
Sai era fatto buio ed io accesi la torcia tenendola bene in vista con la segreta speranza che sarebbe stata vista da qualche nave di passaggio. Il giorno che era passato era stato tremendo, ma la notte si preannunciava peggiore.
Era impossibile dormire perché eravamo sballottati e continuamente bagnati dalle onde. Ero intontito dalla stanchezza e non mi rendevo conto del tempo che trascorreva. Due uomini morirono e gettammo in mare i loro corpi. I pescicani immediatamente li fecero a pezzi e divorarono.
La mattina del lunedì avvistai la nave soccorritrice, l’Albuquerque.
Successivamente venni a sapere che già dal pomeriggio della domenica aveva iniziato il salvataggio dei naufraghi.
Dopo aver trascorso 40 ore in mare, venni portato a bordo della nave. Ero completamente inebetito dalla stanchezza e non mi rendevo conto di nulla, ero come un automa. A me e agli altri ci venne dato del caffè caldo, del brandy e delle coperte. La nave continuò le ricerche e il giorno dopo arrivammo a Lourenco Marques.
Un sopravvissuto, Tiker Brass, che si trovava su una zattera ove c’erano degli italiani e degli inglesi, racconta: Eravamo circa in venti a bordo della zattera in cui mi trovavo e a causa del sovraffollamento, la tensione e lo stress erano molto alti. Ad un certo punto udii che gli italiani dicevano fra di loro: “gli inglesi se ne devono andare”. Ci fu una lotta tremenda e furono invece gli italiani ad essere gettati in acqua. Alcuni galleggiavano con il giubbotto salvagente , altra aggrappati a dei rottami. Dopo un po’ di tempo le correnti li sospinsero lontano da noi e non li vidi più. In quei frangenti sopravvivere era ciò che contava di più e per questo eravamo disposti a tutto.
Al calar delle tenebre i pescicani avevano circondato la nostra zattera e ne vedevamo distintamente le pinne. Si udivano in lontananza le urla strazianti di coloro che venivano attaccati.
Il pomeriggio della domenica l’Albuquerque si fermò vicino alla nostra zattera.
Alla vista della nave sulla zattera ci fu una grande eccitazione, ma c’era anche il timore che ci potesse abbandonare. Invece da bordo fu calata una lancia e noi tutti fummo portati a bordo della nave.
Il caporale Andrew Biccard, appartenente ai Cape Town Higlanderd, testimonia: Avvicinandomi a nuoto ad una zattera, ove si trovavano due prigionieri italiani, con l’intento di salirvi a bordo, venni da questi malamente respinto perché non c’era posto per tre persone. Ma quando i due naufraghi si accorsero che al mio collo pendeva il rosario mariano, immediatamente mi trassero a bordo, facendomi spazio, in quanto si sentirono uniti a me dalla comune fede cattolica.
Ancora dal libro di Tullio Mascellari.
Da: "IL REDUCE D’AFRICA" (data sconosciuta)
Una lapide ad Addi Quala rievoca.
Il Nova Scotia affonda: è la bolgia!
Nel novembra 1942, una nave inglese che trasportava prigionieri italiani dall’Eritrea in Sud Africa venne silurata da un sommergibile germanico: ne derivò una delle più orrende tragedie dei mari. Un superstite racconta.
Addi Quala
“Mi trovo ad Addi Quala, una cittadina dell’Eritrea meridionale. Entro nella chiesa cattolica e vi trovo, fra l’altro, una grande lapide, con sotto una interminabile lista di nomi incisa nella pietra. Si tratta di un ricordo delle vittime di uno dei naufragi più orrendi di tutti i tempi, quella della Nova Scotia. E chi se ne ricorda? Incredibile a dirsi quella tragedia l’Italia l’ha dimenticata. Me la rievoca, nientemeno, uno dei pochissimi superstiti”.
“Tu?”
“Tu? Ma non c’eravamo conosciuti in Mozambico?”
“Sicuro, parecchi anni fa. Adesso, però, vivo fra l’Italia e l’Eritrea”.
“Dire il nome del mio interlocutore, incontrato per caso, non posso, per il ferreo motivo che egli non vuole mettersi in mostra. Ciò che egli mi racconta è infatti troppo atroce, egli afferma, perché da una spaventosa tragedia venga a lui qualsiasi notorietà. Lo chiamerò dunque, il mio interlocutore, Nettuno Marini, visto che di mare, appunto, si tratta”.
Dunque, Eritrea, autunno 1942. La nostra ex colonia si trova da un anno in mano agli inglesi. Prigionieri degli inglesi, molti militari nostri ed anche non pochi internati civili. Buona parte di quei prigionieri, gli inglesi volevano trasferirli in Sud Africa, dove avrebbero potuto gestirli utilmente.
Le nostre navi da guerra che il conflitto aveva bloccato in Eritrea si erano autoaffondate; salvi, invece, gli equipaggi. Donde, appunto, la prigionia. Nettuno Marini faceva parte di uno di quegli equipaggi. E’ il 14 novembre 1942, l’imbarco, a Massaua, sul mercantile britannico Nova Scotia.
Si trattava di un mercantile qualsiasi, vecchio di sedici anni, già adibito alle rotte tra Gran Bretagna e Canada, è però destinato, durante la guerra, alle rotte dell’Africa Orientale: un compito importante, poiché si trattava, tra l’altro, di rifornire il fronte dell’Africa Settentrionale, il quale nel 1942 si era concentrato ad El Alamein. Nel viaggio di ritorno, i prigionieri, nonché una certa quantità di cittadini britannici.
Quanti italiani a bordo? Nonostante le indagini, il numero esatto non si è mai potuto saperlo: massimo, sul migliaio. Si parte dunque alla volta del Sud Africa, esattamente di Durban. Il Nova Scotia era dotato di un certo numero di cannoni, anche antiaerei: si presentava quindi come una nave armata, classico obiettivo di guerra.
“La navigazione si svolgeva regolarmente. Non facevamo parte di alcun convoglio, procedevamo da soli. Usciti dal Mar Rosso sostammo ad Aden dove sbarcammo un nostro commilitone che era stato colto da un attacco di appendicite acuta. La vita a bordo? Noiosa e alquanto penosa: capirai. Oltre mille persone…Ma l’atmosfera della guerra in mare, che io, essendo marinaio, ben conoscevo mancava completamente. Mancava perché nell’Oceano Indiano che mai avremmo potuto incontrare dopo la caduta dell’Africa Orientale Italiana, se non navi alleate? Da qui, appunto, la noia.”
Ma nessuno a bordo della Nova Scotia sospettava. E soltanto parecchi anni dopo la guerra certi dettagli sono venuti a galla.
Comincia, la storia, nella città tedesca di Kiel, sul Mar Baltico – altro che Oceano Indiano! - dal cui porto salpa, il 12 settembre 1942, il sommergibile U- 177. Lo comanda il Kapitanliutenant Robert Gysae, altamente capace. Sottolineato il particolare della capacità perché a Gysae è stata affidata una missione addirittura fantasmagorica: uscire dal Baltico sfidando fra gli stretti della Danimarca, sgusciare attraverso l’insidiosissimo Mare del Nord e poi percorrere tutto l?oceano Atlantico da nord a sud fino al Capo di Buona Speranza (cioè fino al Sud Africa) ed infine operare nell’Oceano Indiano, dove, sino a quel momento, sommergibili tedeschi non se n’erano mai visti e dove quindi le navi alleate si sentivano al sicuro.
“Già, al sicuro ci sentivamo anche noi del Nova Scotia, anche per questo motivo le giornate passavano lentamente, grigie, neutre – dice Nettuno Marini – e poi, fra l’altro, il mare era calmo, il tempo buono”
Sabato 28 novembre 1942, ore 09, 12
L’U-177 ha avvistato col periscopio il Nova Scotia. La nave britannica non si è accorta di nulla. L’U-177 si trova ad appena trecento metri dalla nave nemica, palesemente armata. “Fuori uno! Fuori due! Fuori tre!” Ordina il comandante Gysae. Partono tutti e tre i siluri di prua. Pochi istanti e il Nova Scotia viene come sbudellato, nella sua chiglia si sono aperti tre crateri.
“Quei momenti mi sembrarono, non so come dire, un terremoto, un vulcano, anzi la fine del mondo. Molti di noi stramazzarono a pagliolo, cioè caddero come salami. Ma i corpi si ammonticchiavano perché la nave si era inclinata subito, sulla sinistra. Intanto dilagava, a torrenti, la nafta; le prime fiamme si levarono quasi istantaneamente, dilagando a loro volta e invadendo anche i recessi della nave come le cabine, i corridoi, le stive, dove ancora si trovava moltissima gente; immagina tu che orrore, che bolgia!. Io ebbi la fortuna di poter uscire dalla nave attraverso un corridoio non ancora invaso dalle fiamme, ma gli ustionati erano già moltissimi e il loro numero aumentava di continuo. Non racconto razionale, sai, mi è proprio difficile farlo. Perché bolgia voleva dire caos di fuoco, di un equilibrio nautico che venne meno istantaneamente data l’enormità degli squarci nella chiglia e, nell’ambito di quella inclinazione, tutti cercavano di arrangiarsi – ma di solo istinto, senza il tempo né il modo di ragionare – per salvare la vita. Si cerca di calare in mare una scialuppa, un cavo si spezza, la scialuppa vola con tutto il suo carico umano. Nessuna scialuppa sopravviverà: soltanto qualche zattera. E intanto la nave va giù.
Appena sei minuti – dico: sei minuti – dallo scoppio dei siluri, la nave affonda. Ricordo ancora la sua poppa eretta con le eliche in aria. Qualcuno, sempre d’istinto, a quelle eliche si aggrappò, e, anche se poi finì per mollarle, venne subito risucchiato nell’abisso dalle ottomila tonnellate che sprofondavano.
Continua Marini: “ La pace, finalmente, dopo che il mare aveva spento le fiamme? Oh no, proprio il contrario. Il mare, infatti, si ricopriva di uno strato spesso di nafta, che ci avvelenava. Molti ustionati sopravvivevano, ma in condizioni peggio che atroci. Molti, moltissimi altri cercavano un galleggiante qualsiasi cui aggrapparsi e molto spesso quei tentativi degeneravano in lotte,
forse anche mortali.
D’un tratto il sommergibile emerge. Noi naufraghi quel sommergibile lo guardavamo con incertezza, anche perché un marinaio si era subito precipitato verso la mitragliera di prua. Uno di noi che sapeva il tedesco capì e urlò “ci mitragliano!” ma non fecero in tempo perché noi urlammo a nostra volta, figurati con quanta energia nella voce “Italia, Italia, siamo italiani!” anzi, qualcuno, per renderci istantaneamente credibili, sai cosa fece? Sembra pazzesco, nell’ambito della tragedia, dei morti, degli ustionati, del mare coperto di nafta, ma ecco di che cosa è capace il nostro cervello quando si tratta di vita o di morte: cantò quel commilitone “la donna è mobile, qual piuma al vento…”. A sua volta, il comandante Gysae capì al volo. Fece lanciare due gomene e salvò due di noi. Poi urlò che avrebbe lanciato l’SOS. Dopo di che il sommergibile scomparve”.
“Mi rendo conto che Nettuno Marini cerca di sintetizzare al massimo, anche perché ogni naufrago potrebbe raccontare la peripezia propria; e, in quella circostanza, sono moltissime le vicende proprie che differiscono da quelle altrui.
Per esempio: - c’è uno che galleggia, si, ma parla poco, poi tace: è morto. – Un altro, seminudo, caccia improvvisamente strane urla di dolore, già, non è ustionato né ferito, ma quanto ad ustionarlo provvede un branco di meduse. – Non manca chi decide di suicidarsi, sfilandosi il salvagente. Io no, io un salvagente lo acchiappai subito dopo le esplosioni e non lo mollai più. Un altro urlo orrendo, ma stavolta non si tratta di meduse: l’acqua si tinge di rosa, uno squalo ha morsicato, ha amputato. Saremmo finiti quasi tutti in bocca agli squali se la presenza di tanta nafta non ci avesse, in qualche modo, protetto”.
Il comandante dell’U-177, ben rendendosi conto della gravità del fatto di avere affondato una nave carica di prigionieri italiani, lanciò effettivamente l’SOS; lo lanciò nonostante i rischi che quel segnale gli comportava. Esso venne ricevuto in Germania. E da Berlino partì un messaggio per l’Ambasciata Tedesca a Madrid, e da qui all’Ambasciata a Lisbona, perché quest’ultima chiedesse al Portogallo, neutrale, di intervenire: l’affondamento del Nova Scotia era infatti avvenuto dinnanzi alle coste meridionali del Mozambico, allora possedimento portoghese.
Ebbene, nonostante la guerra, le distanze, le fasi intermedie e internazionali, appena dodici ore dopo il siluramento del Nova Scotia giunse alla fregata portoghese Alfonso de Albuquerque, alla fonda nel porto della capitale mozambicana Lourenco Marques (oggi Maputo), un ordine perentorio per il salvataggio dei naufraghi. Il comandante della nave si trovava al ristorante, in città. Lui si precipitò, provvide a rifornire la nave per una navigazione prevedibilmente lunga, e alle 2, 30 di domenica 29 novembre salpò.
Tredici ore dopo l’avvistamento del primo naufrago e di qualche zattera.
Riprende Nettuno Marini: “Così le cose viste dai portoghesi. Ma per noi andarono in tutt’altro modo. Cioè, anche noi, dopo una tremenda notte passata in mare, avvistammo l’Albuquerque. Senonché i portoghesi, giustamente, in un primo tempo vollero salvare quelli che avevano la minore probabilità di cavarsela, per cui molti di noi, e io ero fra quelli, ad un certo punto videro l’Albuquerque sparire, come se certe zattere, dove si trovavano parecchi naufraghi no lo interessassero. Anche io ero su una zattera. Figurati lo sconforto, la disperazione, oltre all’esaurimento e ai danni fisici!
Nossignore, l’Albuquerque ricomparve, non credevamo ai nostri occhi, salvò tutti quelli che riuscì a raggiungere. Io quando salii sulla nave portoghese, ero nudo come mi aveva fatto la mamma. Appunto, in un certo senso avevo realizzato il sogno di rivedere la mamma. L’Albuquerque sospese le ricerche due giorni e mezzo dopo il nostro affondamento, perché si stava avvicinando uno di quei fortunali che non perdonano”.
La Nova Scotia: 115 italiani salvi (più 64 britannici), 700 o 800 italiani fra morti e dispersi: una cifra, quest’ultima, straziante, che riecheggia l’affondamento del Lusitania nel 1915. Molte salme vennero sospinte dalle correnti sulle coste africane, altre le si recuperò dall’oceano; gli italiani superstiti provvidero a far seppellire ben 120 di quei corpi in tre apposite tombe, presso Durban (Sud Africa) e a dedicar loro una stele.
Dei superstiti nostri, parecchi, rimasero nel neutrale Mozambico, dove appunto conobbi Marini. E i due salvati dall’U-177? Si fecero, per alcuni mesi, una campagna di guerra sottomarina transoceanica, a bordo del sommergibile, con tanto di nuovi siluramenti. Ma ebbero fortuna. Sbarcarono sani e salvi a Bordeaux, in Francia. Rimpatriarono subito.
Un romanzo? Già ma il Nova Scotia diede vita ad un altro romanzo, assai più breve e assai più folle, perché un naufrago italiano, non aiutato da nessuno, riuscì a metter piede, colle sue forze, sulla spiaggia del Sud Africa. Dal momento della catastrofe erano trascorsi…undici giorni!!!
“Altro che film! – conclude Nettuno Marini – ci scapperebbe senz’altro un colossal. Ma bisognerebbe affrettarsi perché noi superstiti, che possiamo raccontare tutto in modo da consentire una sceneggiatura veritiera e completa, ci andiamo rarefacendo”.
“Quanti siete?” Marini è incerto se aprire due mani o una sola”.
Dal sito internet:
http://www.alexcolao.com/753-2/
Nova Scotia - di Allan Jackson
Il peggior disastro marino del Sud Africa è stato il naufragio della Nuova Scozia, a circa 48 km da Capo St Lucia da un U-Boat, il 28 novembre 1942. Era una nave di piccole dimensioni [di 6796 tonnellate] appartenente al Furness Withy Group ed era stato trasformato in un vettore truppa. Era una frequentatrice abituale di Durban, impiegata principalmente nel trasporto di truppe da Durban fino alla costa orientale dell'Africa a Suez e nel riportare prigionieri di guerra italiani in Sud Africa.
Era salpata il 15 novembre da Massawa, nell'Africa orientale italiana, e aveva 765 prigionieri di guerra italiani, 134 guardie britanniche e sudafricane e 118 membri dell'equipaggio a bordo di un U-Boat 177. Il comandante degli U-Boat era Kapitanleutnant Robert Gysae, che fumo apparentemente macchiato dalla Nuova Scozia alle 6:12 del 28 novembre.
L'U-Boat si immerse alle 8:31 e, alle 9:15 del mattino, sparò tre siluri a una distanza di 380 metri, affondando la Nuova Scozia in sette minuti. Una scialuppa di salvataggio è stata lanciata con successo, lasciando il resto dei sopravvissuti aggrappati a zattere o frammenti di relitti nell'acqua infestata da grigi e squali.
L'U-Boat è emerso per scoprire quale nave era affondata, ma il comandante ha notato che non poteva ottenere una risposta perché i sopravvissuti urlavano e gridavano tutti insieme. L'equipaggio era apparentemente sconvolto per le scene che vedevano nell'acqua [vedi U-Boat & a Settler, sotto], ma a bordo erano rimasti solo due sopravvissuti a scopo di intelligence, avendo ricevuto l'ordine di non assistere il resto. L'ordine era datato all'incidente della Laconia il mese prima [vedi HMS Cornwall, sopra], ma il Comando tedesco degli U-Boat informò le autorità portoghesi del naufragio della Nuova Scozia. La nave Alfonso de Albuquerque arrivò sul posto da Lourenco Marques il giorno dopo, e riuscì a salvare 190 sopravvissuti. Un altro fu catturato da un cacciatorpediniere il terzo giorno e un altro fortunato italiano galleggiò a riva su una zattera a Mtunzini, sulla costa dello Zululand,
'unica sopravvissuta è stata Alda Ignisti [più tardi Lady Taylor], che stava andando a Durban con sua figlia Valcheria, dopo essere stata bloccata in Eritrea dalla morte del marito Gastone Ignisti. Un ufficiale dell'esercito britannico di nome Robert Taylor ha organizzato un passaggio per lei sulla Nuova Scozia a Durban perché temeva per la loro sicurezza. Più successivamente ha ricordato l'assoluta confusione a bordo della Nuova Scozia dopo che i siluri hanno colpito, e ha detto che un ufficiale britannico aveva preso Valcheria e saltato in mare con lei, proprio prima che lei saltasse. Dopo aver nuotato a lungo per sfuggire all'aspirazione causata dalla nave che affondava, riuscì a guardarsi attorno e vide in lontananza Valcheria nella sua maglia rossa seduta su una scialuppa di salvataggio che andava alla deriva, per non essere più vista.
Un certo numero di vittime dell'affondamento furono gettate a riva sulle spiagge della KZN e le spoglie di 120, che erano prigionieri di guerra italiani, furono deposte in una fossa comune in quello che più tardi divenne il cimitero militare italiano a Hillary, fuori Durban. Tre croci hanno originariamente segnato la tomba, ma nel 1982, usando una donazione dei sopravvissuti della Nuova Scozia che vivevano ancora in Mocambique, fu eretta una tomba circolare sormontata da una stele rotta che si innalzava dalle onde. Su di esso è inscritto: "Al ricordo dei Figli d'Italia che furono sopraffatti dall'oceano nell'affondamento del S / S 'Nova Scotia' XXVIII-XI-MCMXLII I sopravvissuti al riparo in Mocambique".
Wolfpacks at War [leggi la pagina delle fonti] riporta alcuni estratti del diario di Alfonso de Albuquerque, che raccolse i sopravvissuti della Nuova Scozia. La nave fu inviata in soccorso dalle autorità di Lourenco Marques che erano state informate dell'affondamento da parte del Comando di U-Boat.
Ideatori e curatori del sito: Fiorenzo e Antonio Zampieri
In memoria di Caldiron Luigi Gino
indirizzi di posta: fiorenzo.zampieri@navenovascotia.it - antonio.zampieri@navenovascotia.it
tutti i contenuti del sito sono prelevabili previo consenso da richiedere al seguente indirizzo: redazione@navenovascotia.it







